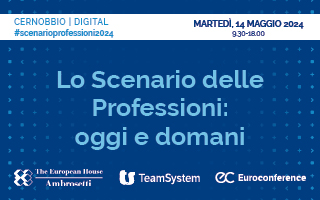Licenziamento per gmo, diritto di repêchage e onere della prova
di Edoardo Frigerio
Il repêchage e la sentenza della Cassazione n.5592/16
Nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, una delle problematiche più insidiose e controverse per gli operatori del diritto, attiene senza dubbio all’istituto del c.d. repêchage ovvero il diritto a favore del lavoratore di salvezza del posto di lavoro nel caso vi siano – al momento del recesso – posizioni lavorative disponibili all’interno dell’organigramma aziendale. Di origine esclusivamente giurisprudenziale e proprio solo dei licenziamenti per gmo – ovvero, come noto, quelli regolati dall’art.3, L. n.604/66, e determinati da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa – il diritto di repêchage angustia da anni le notti di datori di lavoro e consulenti per via della spesso incoerente elaborazione giurisprudenziale che ne ha delineato le caratteristiche e gli effetti. Tale elaborazione, nel corso dei decenni, ha stabilito come il licenziamento possa essere considerato legittimo solo quando costituisca un’extrema ratio e non sia possibile, per il datore di lavoro, alcun salvataggio del lavoratore nell’organizzazione produttiva, ad esempio attraverso l’adibizione dello stesso a mansioni diverse. Come noto, l’art.5, L. n.604/66, grava il datore di lavoro dell’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo (in questo caso oggettivo) di licenziamento. Tale onere probatorio riguarda quindi, da un lato, la concreta riferibilità del provvedimento di recesso a ragioni di carattere produttivo-organizzativo, la cui esistenza deve essere anch’essa provata; dall’altro attiene alla dimostrazione dell’impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita: in tali ambiti si concreta, quindi, il c.d. diritto di repêchage del lavoratore che subisca il licenziamento per motivi economici.
Anche recentemente, la Cassazione (Cass. sent. n.3234/14) poneva le seguenti regole al fine di individuare il contenuto del diritto di repêchage:
- il datore di lavoro doveva dare prova di non poter ricollocare il lavoratore in esubero in altra posizione lavorativa disponibile;
- il lavoratore doveva fornire elementi atti ad individuare, all’interno della compagine aziendale, posti di lavoro liberi compatibili con il suo bagaglio professionale;
- se il lavoratore forniva le allegazioni di cui al punto precedente, scattava l’ulteriore onere a carico del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità del dipendente nelle posizioni lavorative indicate dal lavoratore come disponibili.
Il lavoratore che pretendeva la violazione del diritto di repêchage, in conseguenza di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, aveva quindi processualmente l’onere di allegazione al riguardo dell’esistenza di posizioni lavorative disponibili del datore di lavoro che lo aveva licenziato (con la precisazione che tale onere di allegazione, cioè di affermazione in giudizio di fatti, non è un onere di prova, cioè di dimostrazione di fatti, stante la previsione dell’art.5, L. n.604/66, per cui la prova del licenziamento grava, come detto, interamente sul datore di lavoro).
Questo onere di allegazione era considerato quindi come un obbligo, per il lavoratore, di rappresentazione di fatti da cui poter far derivare il diritto al repêchage. Tali fatti non potevano che avere per oggetto l’indicazione di posizioni lavorative disponibili all’interno dell’azienda: il suddetto onere di allegazione non poteva, però, essere assolto dal lavoratore mediante deduzioni generiche circa eventuali posizioni lavorative fruibili, essendo necessario che venissero date indicazioni specifiche circa mansioni o ruoli liberi nel complesso aziendale.
Tale tradizionale impostazione è ora messa in crisi da un recentissimo revirement della Cassazione, che, con la sentenza n.5592 dello scorso 22 marzo, è tornata ad occuparsi — in un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo — di repêchage con esiti abbastanza imprevedibili.
Nella vicenda posta all’attenzione della Suprema Corte, sia il giudice di prime cure sia quello dell’impugnazione avevano ritenuto il licenziamento di un lavoratore per motivi economici da parte di un’azienda del tutto legittimo, ciò in base a dati di bilancio negativi dell’impresa, di altri licenziamenti operati precedentemente nello stesso reparto e dell’ammissione della società alla cassa integrazione. La Corte d’Appello aveva, quindi, ritenuto provata l’effettiva ricorrenza del giustificato motivo oggettivo, conseguente a riorganizzazione aziendale a causa dell’andamento economico e finanziario negativo del datore di lavoro. Ciò anche in considerazione dell’assenza di specifica allegazione da parte del lavoratore di possibili ruoli alternativi all’interno dell’azienda, laddove potesse essere realizzato un utile repêchage nei confronti del lavoratore. Quest’ultimo ricorreva allora in Cassazione per non aver a suo dire il giudice d’appello:
- in primo luogo motivatamente escluso l’onere di repêchage da parte della società datrice di lavoro;
- in secondo luogo per erronea ripartizione dell’onere della prova, non posto a carico integralmente al datore di lavoro, senza la necessità di alcun coinvolgimento collaborativo del lavoratore, come invece postulato dal giudice dell’impugnazione.
La Suprema Corte, piuttosto imprevedibilmente, accoglieva il ricorso del lavoratore e cassava la sentenza d’Appello – rinviando la causa alla corte d’origine (in altra composizione) e fornendo una ricostruzione alternativa dell’onere della prova in tema di repêchage che così si riassume. La Corte premetteva di avere consapevolezza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se l’onere della prova dell’impossibilità di impiegare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita è a carico del datore di lavoro, tuttavia esso conseguirebbe da un diverso e propedeutico onere, a carico dello stesso lavoratore che impugni il licenziamento, di allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro per la sua utile ricollocazione, in virtù di un preteso obbligo di collaborazione nell’accertamento di un possibile repêchage in una sorta, per così dire, di cooperazione processuale. A questo punto la sentenza in commento ha affermato che: “come chiaramente si evince dall’integrale lettura delle sentenze citate, un tale indirizzo imperniato su una netta (e inedita) divaricazione tra onere di allegazione (in capo al lavoratore) e di prova (in capo al datore di lavoro) è meramente tralaticio, fondandosi su una petizione di principio (secondo cui “il lavoratore, pur non avendo il relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilità di repêchage”) assunta come postulato, in quanto affatto argomentata nel suo fondamento giuridico”.
In sostanza, secondo la sentenza n.5592 in esame, tale supposto onere di allegazione a carico del lavoratore trarrebbe origine da risalenti sentenze della Cassazione — poi automaticamente e acriticamente ribadite dalle sentenze successive — che avrebbero non fondatamente affermato che la possibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni diverse era elemento costitutivo della domanda di impugnazione del lavoratore del licenziamento per giustificato motivo oggettivo stesso, con conseguente suo obbligo di allegazione della possibilità di una diversa e adeguata utilizzazione all’interno dell’azienda. Viceversa, ha evidenziato la sentenza, se è indubbio che nel giudizio di impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo la causa petendi sia data dall’inesistenza dei fatti giustificativi del potere spettante al datore di lavoro, gravando su quest’ultimo l’onere di provare la concreta sussistenza delle ragioni inerenti all’attività produttiva e l’impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, è pur vero che l’indicazione (pur “possibile” da parte del “lavoratore” che si sia fatto “parte diligente”) di un posto di lavoro alternativo a lui assegnabile, o l’allegazione di circostanze idonee a comprovare l’insussistenza del motivo oggettivo di licenziamento, non può comportare l’inversione dell’onere della prova.
Poiché, quindi, l’art.5, L. n.604/66, è assolutamente chiaro nel porre a carico del datore di lavoro l’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, in esso deve necessariamente rientrare anche la prova dell’impossibilità di repêchage, quale criterio di integrazione delle ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa; ciò nella modulazione della loro diretta incidenza sulla posizione del singolo lavoratore licenziato, derogabile soltanto quando il motivo consista nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile ovvero in caso di licenziamento del dirigente per incompatibilità del repêchage con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro (Cass. n.3175/13) e mitigata da tutele solo contrattuali.
Secondo la sentenza in commento, pertanto, la domanda del lavoratore sarebbe correttamente individuata a norma dell’art.414 c.p.c., nn.3 e 4, da un petitum di impugnazione del licenziamento per illegittimità e da una causa petendi di inesistenza del giustificato motivo così come intimato dal datore di lavoro, cui incombe pertanto la prova, secondo la previsione dell’art.5, L. n.604/66, della sua ricorrenza in tutti gli elementi costitutivi, in essi compresa l’impossibilità di repêchage, senza alcun onere sostitutivo del lavoratore alla sua controparte datrice sul piano dell’allegazione, per farne conseguire un onere probatorio.
Conseguentemente, in base a tali principi “il creditore attore (lavoratore impugnante il licenziamento come illegittimo) è onerato della (allegazione e) prova della fonte negoziale (o legale) del proprio diritto (rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e dell’allegazione dell’inadempimento della controparte (illegittimo esercizio del diritto di recesso per giustificato motivo oggettivo), mentre il debitore convenuto (datore di lavoro) è onerato della prova del fatto estintivo (legittimo esercizio del diritto di recesso per giustificato motivo oggettivo nella ricorrenza dei suoi presupposti, tra i quali, come detto, anche l’impossibilità di repêchage): in coerenza con i principi di persistenza del diritto (art. 2697 c.c.) e di riferibilità o vicinanza della prova”.
La Corte, pertanto, nel cassare la sentenza, ha posto il principio in base al quale, in materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repêchage del lavoratore licenziato, in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento, con esclusione di un onere di allegazione al riguardo del lavoratore, essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i due suddetti oneri, entrambi spettanti alla parte datoriale.
Oneri probatori nel repêchage: capitolo chiuso?
La sentenza sopra descritta potrebbe porre nuove problematiche al datore di lavoro, in caso di licenziamento per gmo. Sino a ora, infatti, in base al diverso orientamento giurisprudenziale che pareva assolutamente dominante, l’onere probatorio a carico del datore di lavoro di dimostrare l’impossibilità di “ripescaggio” appariva piuttosto agevole — nel caso non vi fossero deduzioni del lavoratore circa eventuali posti disponibili — attraverso la dimostrazione della mancata assunzione di nuovo personale per un congruo periodo di tempo, nell’ambito dell’intero complesso aziendale. Viceversa, quando il dipendente avesse allegato in causa precise indicazioni al riguardo di posti disponibili, anche in mansioni inferiori, scattava per il datore di lavoro l’ulteriore obbligo di provare la non utilizzabilità del dipendente licenziato nelle posizioni lavorative indicate dal lavoratore come disponibili, dovendosi dare altresì la dimostrazione dei reali sforzi fatti in concreto dalla parte datoriale nell’assolvimento del predetto obbligo di repêchage, dimostrazione non certo semplice, specialmente nelle realtà imprenditoriali più grandi.
Adesso, sulla base dei principi evidenziati dalla sentenza n.5592/16 – ma vedremo dopo le ulteriori sentenze “dissonanti” – il datore di lavoro sarà tenuto a dare dare prova più rigorosa dell’impossibilità di ricollocare il dipendente in posizione lavorativa compatibile.
Ma per quanto riguarda eventuali posizioni lavorative disponibili in mansioni inferiori?
Tradizionalmente, secondo la giurisprudenza, l’onere di provare l’impossibilità di repêchage era limitato alle mansioni equivalenti a quelle proprie del lavoratore licenziato, senza che potessero essere contemplate le mansioni inferiori, in ossequio al generale principio di divieto di demansionamento, stabilito dall’art.2103 cod.civ. (nella sua formulazione anteriore al D.Lgs. n.81/15). Tale consolidato orientamento era stato incrinato negli ultimi anni da alcune sentenze della Suprema Corte: in alcune pronunzie (Cass. n.8596/07; Cass. n.21579/08) il giudice di legittimità aveva precisato come la disposizione dell’art.2103 cod.civ. andasse interpretata alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito dei processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, a quelle precedentemente svolte (restando immutato il livello retributivo) non si poneva in contrasto con il dettato codicistico, se essa rappresentava l’unica alternativa praticabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Al riguardo non vi è stata, però, uniformità in giurisprudenza: sentenze della Cassazione successive (Cass. n.6552/09; Cass. n.3224/14) hanno stabilito come il repêchage in mansioni inferiori potesse operare solo in presenza di un preesistente “patto di demansionamento”; viceversa, una pronuncia del 2012 (Cass. n.6501/12) aveva evidenziato l’onere dell’azienda di verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in esubero anche in mansioni inferiori, sempre che tali mansioni fossero proficuamente utilizzabili all’interno dell’impresa, senza alterazioni dell’organigramma aziendale.
Ulteriori sentenze della Suprema Corte hanno evidenziato la sussistenza di contrasto giurisprudenziale circa la ricollocabilità in mansioni inferiori:
- alcune (Cass. n.20918/13; Cass. n.18025/2012; Cass. n.6/13) hanno affermato, senza ulteriori specificazioni, l’esistenza di un onere a carico del datore di lavoro di dimostrare l’incollocabilità del lavoratore licenziato in mansioni anche inferiori;
- altre (Cass. n.7515/12) hanno presupposto che la sussistenza di mansioni inferiori, esistenti e comunque utili per l’impresa, siano state proposte e rifiutate dal lavoratore prima del licenziamento;
- si è inoltre precisato (Cass. n.6552/09) che, ove i lavoratori abbiano accettato mansioni inferiori onde evitare il licenziamento, la prova dell’impossibilità di repêchage vada fornita anche con riferimento a tali mansioni, ma occorre, in quest’ultimo caso, che il patto di demansionamento sia anteriore o coevo al licenziamento, mentre esso non può scaturire da una dichiarazione del lavoratore espressa in epoca successiva al licenziamento e non accettata dal datore di lavoro, specie se il lavoratore abbia in precedenza agito in giudizio deducendo l’illegittimità del licenziamento.
Tutto chiaro quindi? Assolutamente no.
Tutta la questione del repêchage, anche in mansioni inferiori, e del relativo onere probatorio come delineato dalla sentenza n.5592/16, viene messa in discussione, appena quaranta giorni dopo, dalla sentenza della Cassazione, sez. Lavoro, n.9467 del 10 maggio 2016. Cambia la composizione dei giudici della Corte e, disconoscendo la sentenza appena presa, cambia metro di giudizio.
In tale ultimissima pronuncia – in cui si opinava del licenziamento di una lavoratrice (inquadrata come impiegata) per soppressione del posto di lavoro e della violazione del repêchage, avendo il datore di lavoro (un albergo) evidenziato come l’unico posto libero disponibile (di cameriera) fosse incompatibile con la professionalità della lavoratrice – è stato ribadito come il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi e indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. Tale prova, secondo la sentenza di maggio, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile repêchage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.
Sul punto, pertanto, la sentenza n.9467/16 non tiene in considerazione la sentenza n.5592/16, che, pochi giorni prima, era arrivata a conclusioni inverse.
Non solo. Alla censura della lavoratrice circa l’esistenza di un posto di lavoro all’interno dell’azienda, seppur in mansioni inferiori, la sentenza ha affermato che il demansionamento, a prescindere dall’accettazione o meno da parte del lavoratore e dunque dall’esistenza di un patto di demansionamento, è ammissibile sempre che ci sia una certa omogeneità con i compiti originariamente svolti dal lavoratore; il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha poi l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa (alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte), ma anche l’insussistenza di mansioni inferiori rientranti e compatibili con il bagaglio professionale dei lavoratore. Peraltro, a precisazione di tale affermazione, la Corte ha evidenziato che non vi è un obbligo del datore di lavoro di offrire al lavoratore tutte le mansioni possibili, anche quelle del tutto incompatibili con quelle svolte in precedenza dal lavoratore: nel caso di specie, la lavoratrice era inquadrata con mansioni di segretaria, ricevimento e cassa e, in generale, con compiti amministrativi; l’unica mansione ritenuta disponibile era, viceversa, quella di cameriera, che non solo era inferiore a quella svolta dalla lavoratrice, ma era del tutto avulsa dal bagaglio professionale e dalle competenze della dipendente e, dunque, non era ravvisabile un obbligo della società di offrire dette diverse mansioni alla lavoratrice licenziata.
Se le conclusioni della sentenza n.9467/16 paiono condivisibili in tema di ricollocabilità in mansioni inferiori, non essendo seriamente dubitabile che possa essere offerta o pretesa da un quadro o impiegato un posto da operaio – ciò anche con una certa coerenza con la nuova formulazione dell’art.2103 cod.civ. che esclude la possibilità di adibire a mansioni inferiori di categoria legale diversa – sorprendenti sembrano le affermazioni in tema di onere della prova se, come detto, confrontate con quelle della sentenza n.5592 di poche settimane prima.
Ciò porrà senz’altro il datore di lavoro, specie quello di grandi dimensioni, in una situazione processuale sfuggente in caso di impugnazione di licenziamento e contestazione del mancato repêchage senza allegazioni da parte del lavoratore, essendo dubbio se in questo caso il datore possa esimersi dalla prova della ricollocabilità (in assenza appunto di allegazioni del lavoratore) o debba spingersi alla prova dell’impossibilità del “ripescaggio” in qualsiasi mansione, purché della stessa categoria e comunque compatibile con la professionalità del lavoratore.
Le conseguenze del mancato repêchage tra L. n.92/12 e D.Lgs. n.23/15
Visti i contrasti in tema di onere di allegazione, meno criticità si rilevano nell’individuare le sanzioni nel caso il datore di lavoro sia caduto nella violazione del repêchage. Se “anticamente”, sino ai licenziamenti intimati al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. n.92/12), le conseguenze a carico del datore di lavoro che non avesse rispettato l’onere di repêchage erano la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, in base alla preesistente formulazione dell’art.18, L. n.300/70, da tale fatidica data il “nuovo” art.18, co.7, prevede la sanzione della reintegrazione e dell’indennità risarcitoria (nell’importo massimo di 12 mensilità) in caso di “manifesta insussistenza” del motivo oggettivo posto dal datore di lavoro, mentre il giudice “nelle altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo” applicherà solo la sanzione risarcitoria da 12 a 24 mensilità. Tale norma si applica però solo ai “vecchi” assunti, mentre per i nuovi assunti dal 7 marzo 2015 (ancor più fatidica data di entrata in vigore del D.Lgs. n.23/15 e del contratto “a tutele crescenti”) si applica – in caso di licenziamento per gmo – la previsione dell’art.3 di quest’ultima legge. Come noto, tale articolo, al co.1, stabilisce che qualora il giudice, all’esito del giudizio, rilevi l’assenza di giustificato motivo oggettivo del licenziamento “dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.
Tali regole valgono per i dipendenti di imprese con più di quindici dipendenti nella sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo al quale era addetto il lavoratore licenziato, o con più di quindici dipendenti nello stesso Comune o, comunque, con più di sessanta dipendenti. Per i licenziamenti economici dei lavoratori assunti dal 7 marzo (o il cui contratto a tempo determinato o di apprendistato sia stato trasformato a tempo indeterminato, o ancora per i dipendenti assunti precedentemente da datori di lavoro che in seguito a nuove assunzioni abbiano integrato il requisito occupazionale di cui all’art.18, L. n.300/70) è quindi esclusa sia la reintegrazione nel posto di lavoro – tranne il caso che il licenziamento per gmo celi un licenziamento discriminatorio o ritorsivo – sia la discrezionalità del giudice sull’ammontare dell’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo.
Per i “vecchi assunti”, viceversa, si continueranno ad applicare le tutele dell’art.18, L. n.300/70, ovvero il risarcimento da dodici a ventiquattro mensilità (graduabile dal giudice in relazione all’anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti) in caso non ricorrano gli estremi del predetto giustificato motivo oggettivo; nel caso, invece, di “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, l’applicazione dell’art. 18 ai “vecchi assunti” potrà comportare la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento sino a dodici mensilità. L’art.4 del decreto legislativo prevede poi, in caso di vizio formale consistente in “violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966” che le tutele siano dimezzate con la previsione di una sola mensilità risarcitoria per anno di servizio, con un minimo di due e un massimo di dodici mensilità. Si deve ricordare inoltre come, per i nuovi assunti delle piccole imprese con meno di quindici dipendenti, il D.Lgs. n.23/15 preveda, entro il limite massimo risarcitorio di sei mensilità e minimo di due, il dimezzamento delle indennità previste per i lavoratori dipendenti di aziende con più di quindici dipendenti. In caso di violazione dell’obbligo di indicazione o specificazione dei motivi del licenziamento economico, l’indennizzo a favore dei “nuovi assunti” delle piccole imprese sarà pari a mezza mensilità per anno di servizio, con un minimo di una mensilità e un massimo di sei. In questo caso si è di fronte quindi a una tutela ancora inferiore rispetto alla già limitata “tutela obbligatoria” prevista per le piccole imprese dall’art.8, L. n.604/66. Per i lavoratori “nuovi assunti”, quindi, in caso di violazione dell’obbligo di repêchage e di conseguente illegittimità del licenziamento, le sanzioni sono ora automaticamente e rigidamente determinate dalla normativa del 2015.
Come detto, diversa e più rilevante è la tutela per i “vecchi assunti” (sino al 7 marzo 2015) in caso di violazione del repêchage. Al riguardo le sentenze dei Tribunali del lavoro si sono orientate nel ritenere che da tale vizio del licenziamento consegue la tutela indennitaria “forte” (nella misura da 12 a 24 mensilità) prevista dal co.7, art.18, Statuto dei Lavoratori. Ovviamente l’applicabilità della sola tutela risarcitoria ha come presupposto la non manifesta insussistenza dei motivi del licenziamento, ovvero la prova (da parte del datore di lavoro) dell’esistenza delle ragioni economiche e organizzative causative della soppressione del posto di lavoro. In tali casi l’inosservanza della possibilità di ricollocazione del lavoratore licenziato in altri ambiti aziendali da parte del datore di lavoro può quindi avere la conseguenza in capo al datore di lavoro del “pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti”.
I Tribunali del lavoro interessati da contenziosi sulla violazione del repêchage si sono indirizzati, come detto, verso tale interpretazione della norma sin dai primi tempi della sua entrata in vigore. Ad esempio, il Tribunale di Milano, in presenza di un’impugnazione del lavoratore che aveva richiesto la reintegrazione nel posto di lavoro, con ordinanza 28 novembre 2012 aveva condannato il datore di lavoro all’indennità risarcitoria “forte” (20 mensilità) di cui al co.5, art.18, poiché il datore di lavoro aveva dato prova dei fatti posti alla base del licenziamento, ma non aveva assolto all’onere di dimostrare l’impossibilità di repêchage all’interno della sua compagine produttiva.
Spostandoci nella città eterna, il Tribunale di Roma, sez. lavoro, con ordinanza 8 agosto 2013, ritenendo (in una controversia di impugnazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo) che vi fosse stata violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di ricollocazione del lavoratore, in considerazione dell’anzianità lavorativa del lavoratore abbastanza elevata, del numero dei dipendenti e del comportamento delle parti, aveva condannato l’impresa al pagamento del risarcimento nella misura di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Ancora sulla stessa linea il Tribunale di Varese (2 settembre 2013), che, ponendosi il quesito se (in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro) il mancato adempimento dell’obbligo di repêchage rientrasse o meno nel “fatto” la cui manifesta insussistenza dia luogo alla reintegrazione nel posto di lavoro, ha evidenziato come l’ipotesi di cui si discute esulasse propriamente dal concetto di “fatto posto a fondamento del licenziamento” (la cui manifesta insussistenza può indurre il giudice ad applicare la tutela reintegratoria “attenuata” di cui al co.4, art.18) e dovesse essere ricollegata alle “altre ipotesi in cui il Giudice, pur accertando profili di illegittimità del licenziamento, dichiara comunque il rapporto di lavoro risolto e si limita a condannare il datore di lavoro a risarcire il danno” (l’azienda in questo caso veniva condannata al risarcimento nel limite minimo nella misura di dodici mensilità, in considerazione del fatto che l’impresa, seppur dopo il licenziamento e quindi tardivamente, aveva offerto una posizione lavorativa all’ex dipendente, rifiutata da quest’ultimo senza valide ragioni).
Più recentemente il Tribunale di Milano (n.3064/15), in linea con le sentenze sopra richiamate, ha reputato che la conseguenza della violazione dell’obbligo di repêchage sia rappresentata dalla c.d. tutela indennitaria forte di cui all’art.18, co.5 e 7, L. n.300/70, da applicarsi in via logicamente prioritaria rispetto al co.6; conseguentemente il Tribunale, tenuto conto dell’anzianità dei lavoratori, delle dimensioni dell’attività economica e delle condizioni e comportamento delle parti, quantificava nel minimo di dodici mensilità il risarcimento a favore del lavoratore.
In conclusione, si può ritenere come la questione degli esatti limiti e contenuto del diritto al repêchage sia destinata ad avere ancora ampio seguito giurisprudenziale, come dimostra la non uniformità delle sentenze della Cassazione sopra descritte. Viceversa, sulle tutele applicabili in caso di licenziamento illegittimo per violazione del repêchage, le sentenze di merito paiono, al contrario, aver individuato nel solo ristoro economico le conseguenze del recesso invalido: per i “vecchi” assunti la discrezionalità degli importi risarcitori appare ancora abbastanza rilevante, mentre per i “nuovi” assunti a tutele crescenti gli importi saranno sempre predefiniti per legge e, quantomeno per i primi anni di bassa anzianità, molto inferiori a quelli invocabili dagli assunti ante 7 marzo 2015.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Il giurista del lavoro“.