Chi di 2103 ferisce di 2103 perisce, ovvero le perigliose vicissitudini dello ius variandi datoriale…
di Marco Frisoni
Oramai si tratta di un fatto oggettivamente inesorabile; qualunque tematica di diritto del lavoro alla fine porta sempre a un’accesa discussione sulla bontà delle novelle apportate dal Jobs Act nel suo complesso.
Va da sé che, in una siffatta angolazione, a tale destino non poteva di certo sfuggire l’intricata vicenda delle modifiche apportate all’articolo 2103 cod. civ., con precipuo riguardo alla prerogativa datoriale di modificare in via unilaterale le mansioni del prestatore di lavoro subordinato.
In effetti, a ben vedere, le modificazioni dovute all’avvento del D.Lgs. 81/2015 non potevano, in concreto, passare inosservate, non foss’altro perché incidenti su un vero e proprio totem del diritto del lavoro, i cui contenuti, prima del Jobs Act, derivavano dallo Statuto dei Lavoratori e, pertanto, erano considerati baluardo e simulacro delle tutele a beneficio dei lavoratori dipendenti.
Non solo; si deve considerare che l’intervento sull’articolo 2103 cod. civ. è da inserirsi in un contesto dove, a seguito della Legge delega 183/2014, l’uscente Governo Renzi ha destrutturato i più rilevanti e storici simboli dell’avanzamento delle asserite protezioni dei lavoratori, quali l’articolo 4 (con l’affievolimento, o presunto tale, della disciplina in materia di controlli a distanza) e l’articolo 18, in virtù delle c.d. tutele (de)crescenti, sempre dello Statuto dei Lavoratori, che, in verità, appare ampiamente mutato (mutilato, secondo le organizzazioni sindacali) per opera del Jobs Act.
Tornando all’articolo 2103 cod. civ., come è noto, il Legislatore ha ritenuto opportuno, in una logica di maggiore flessibilità organizzativa, che ai più appare indispensabile per affrontare le nuove sfide dei mercati globali di riferimento delle aziende nostrane, rendere meno rigido e difficoltoso l’esercizio dello ius variandi datoriale, vale a dire il potere di variazione delle mansioni svolte dal lavoratore.
In buona sostanza, si è passati dal tradizionale (e rigoroso) approccio dell’equivalenza soggettiva e oggettiva, con relativa analisi concreta, delle mansioni di partenza rispetto a quelle di destinazione quale limite del suddetto potere datoriale a un meccanismo che, avendo in parte recepito degli orientamenti giurisprudenziali nel tempo stratificatisi, consente al soggetto datore di lavoro di operare lo ius variandi “orizzontale”, a condizione che le nuove incombenze del prestatore di lavoro siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
È del tutto evidente che, in una siffatta visione prospettica, la norma in analisi appare modulare in maniera maggiormente duttile la modificazione delle mansioni assegnate al lavoratore, che, a questo punto, incontrano il limite della categoria legale (articolo 2095 cod. civ.) e, soprattutto, dei sistemi di inquadramento che derivano dalla contrattazione collettiva applicata.
Tutto ciò deve essere altresì letto con le ulteriori novità apportate al testo dell’articolo 2103 cod. civ., in special modo rammentando che, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale e che, nelle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Se, da un lato, si è salutata la novella come una vera e propria rivoluzione storica del diritto del lavoro (naturalmente, insieme alle ulteriori iniziative riferibile al Jobs Act), non pochi commentatori si sono interrogati sui riflessi che la nuova disciplina così strutturata avrebbe potuto comportare, di riflesso, per altre questioni che ne sono legate vuoi per disposizioni di legge che per arresti giurisprudenziali.
Si pensi, ad esempio, al c.d. “obbligo di repêchage”, frutto della fervida fantasia della nostra magistratura, in una logica di considerare il licenziamento quale ultima ed estrema misura, adottata dopo che il datore di lavoro, anche in virtù dei generali canoni di correttezza e buona fede, abbia valutato la possibilità di adibire il lavoratore ad altre funzioni e/o accertato che non vi siano altre opportunità di ricollocazione, anche esterne all’azienda.
Ecco dunque che il nuovo dettato legale in materia di mansioni estende, in concreto, la dimensione dell’obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro, che, almeno per la parte afferente all’indagine intorno alla presenza o meno di posizioni lavorative in “orizzontale”, dovrà tenere in considerazione l’esigenza di spingere tale analisi prendendo a parametro e riferimento il nuovo confine della categoria legale e del livello di inquadramento.
Questo adempimento, con il corollario giurisprudenziale che impone una verifica anche sulle mansioni inferiori eventualmente reperibili e che sempre più addossa al datore di lavoro l’onere della prova sull’impossibilità di soddisfare il ripescaggio del lavoratore in predicato di essere estromesso, è foriero di un panorama di rischi di causa non indifferenti, attenuati da due fattori:
- la tenue tutela, meramente indennitaria, offerta per i nuovi assunti con le tutele crescenti;
- per i vecchi assunti, il crescente orientamento della giurisprudenza che, in caso di vizio sull’obbligo di repêchage, per i datori di lavoro soggetti all’articolo 18, L. 300/1970 (dopo le modifiche apportate, nel 2012, dalla Legge Fornero), appare propenso a non riconoscere al lavoratore la reintegrazione sul posto di lavoro, a favore del risarcimento del danno in forma monetaria, da 12 a 24 mensilità.
La sentenza n. 3370 del 16 dicembre 2016 del Tribunale di Milano (quindi un foro di notevole importanza) ha affermato che il datore di lavoro in presenza di un lavoratore eccedentario da licenziare per giustificato motivo oggettivo, deve verificare la sussistenza, nell’ambito dell’intera azienda, non più delle mansioni equivalenti, ma tra tutte le mansioni riconducibili allo stesso livello della categoria legale di inquadramento.
In altre parole, i giudici meneghini richiamano il datore di lavoro sul fatto che, a fronte dell’ampliamento dei contenuti dello ius variandi, come altro lato della medaglia appare una maggiore gravosità del percorso che si dovrà imboccare al fine di soddisfare in giudizio l’obbligo di repechage, con tutte le conseguenze del caso.
Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:




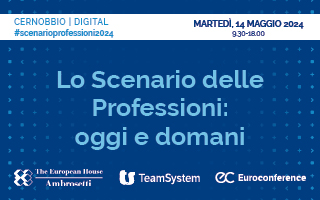




17 Marzo 2017 a 12:25
l’obbligo di repêchage è un strumento fittizio di demansionamento del lavoratore, come riportato nell’intervento è possibile davanti alle commissioni di certificazione la stipula di accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
nelle critiche condizioni economiche che si vivono qui in Italia ho fatto esperienza in prima persona di queste conciliazioni per la conservazione del posto di lavoro anche a prezzo di decurtazioni dello stipendio non certo per un miglioramento delle condizioni di vita.
certo meglio mantenerlo il posto di lavoro e la magistratura così come i sindacati dovrebbero iniziare a capirlo!!
17 Marzo 2017 a 12:37
Concordo con le valutazioni formulate, anzi direi che l’intensità sempre maggiore dei contenuti con cui “colorare” l’obbligo di repechage non solo appare figlia dei tempi critici che ancora si vivono sul piano dei livelli occupazionali (si accettano notevoli detrimenti del trattamento economico e/o contrattuale pur di conservare il posto di lavoro) ma risulta, per l’appunto, oggi formalmente cristallizzata all’interno del “novellato” art. 2103 del codice civile, avendo infine il legislatore accolto suggestioni che, in precedenza, provenivano da orientamenti della giurisprudenza.