Doppia retribuzione al lavoratore ceduto a seguito di trasferimento d’azienda dichiarato illegittimo?
di Roberta Villani - Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati
La pronuncia n. 29/2019 della Corte Costituzionale trae origine dall’ordinanza di rimessione della Corte d’Appello di Roma, formulata nell’ambito di un giudizio promosso dalla società datrice di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che, a seguito della cessione di un ramo d’azienda dichiarata illegittima, aveva riconosciuto anche in capo a tale società – in qualità di cedente del ramo – l’obbligo di pagare le retribuzioni al lavoratore ceduto, anche se già corrisposte dalla società cessionaria. La Corte di’Appello di Roma, con ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del 2 ottobre 2017, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1206, 1207 e 1217, cod. civ., per violazione degli articoli 3, 24, 111 e 117, comma 1, Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu). La Corte rimettente ha censurato le citate norme, relative all’istituto della mora del creditore sul presupposto che queste ultime – così come interpretate dal diritto vivente – limitassero, di fatto, la tutela del lavoratore ceduto al mero risarcimento del danno, nonostante l’accertamento definitivo della nullità, dell’inefficacia e/o dell’inopponibilità della cessione del ramo di azienda.
Secondo la Corte rimettente l’accertamento dell’illegittimità del trasferimento del ramo d’azienda determinerebbe la ricostituzione con effetti retroattivi del rapporto di lavoro alle dipendenze della società cedente, conferendo, pertanto, al lavoratore il diritto di reclamare la retribuzione sia nei confronti di quest’ultima, sia nei confronti della società cessionaria, che beneficia della prestazione lavorativa in applicazione dell’articolo 2126 cod. civ.. Di conseguenza, secondo la Corte d’Appello di Roma, l’obbligazione della società cedente avrebbe natura risarcitoria per il periodo intercorrente fra la cessione del ramo di azienda e la sentenza di accertamento della sua l’illegittimità, mentre acquisterebbe natura retributiva per il periodo successivo a tale pronuncia. Tuttavia, l’orientamento sino a quel momento consolidato e costante della Corte di Cassazione negava al lavoratore ceduto, già retribuito dal cessionario, il diritto di percepire la retribuzione da parte del datore di lavoro moroso rispetto all’obbligo di ricostituzione del rapporto di lavoro. Di qui le censure del giudice a quo, secondo il quale la disciplina della mora credendi, come interpretata e accreditata dal diritto vivente – che riconosce una responsabilità meramente risarcitoria del datore di lavoro per il periodo successivo alla dichiarazione di nullità della cessione del ramo d’azienda – contrasterebbe con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3, Costituzione. In particolare, tale interpretazione determinerebbe una disparità di trattamento sia in riferimento alla disciplina di tutti gli altri rapporti contrattuali diversi da quello di lavoro subordinato, sia in riferimento alla disciplina sulla nullità dell’apposizione del termine, per il periodo successivo alla sentenza. Tale interpretazione, inoltre, comporterebbe anche la lesione di altri principi costituzionalmente tutelati: l’effettività della tutela giurisdizionale (articolo 24, Costituzione), poiché consentirebbe al datore di lavoro di sottrarsi ad libitum alla sentenza anche passata in giudicato; il giusto processo (articolo 111, Costituzione), inscindibilmente connesso con l’effettività della tutela; il processo equo (articolo 117, Costituzione, in relazione all’articolo 6, Cedu).
Ebbene, una volta delineato il tema su cui la Corte Costituzionale è stata chiamata a esprimersi, quest’ultima ha rilevato che – nelle more del procedimento costituzionale – sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2990/2019, che si è dovuta pronunciare proprio sull’annosa questione relativa alla natura retributiva o risarcitoria delle somme spettanti al lavoratore, che, dopo aver offerto la prestazione a seguito della declaratoria giudiziale di illecita interposizione di manodopera, non è stato riammesso in servizio. Nella complessa opera ricostruttiva, le Sezioni Unite, riprendendo l’orientamento maggioritario che si è formato dapprima in tema di conseguenza della nullità del trasferimento d’azienda, per poi estenderlo alla fattispecie di interposizione illecita di manodopera, hanno puntualizzato che la qualificazione risarcitoria – con la conseguente detraibilità del c.d. aliunde perceptum – dell’obbligazione del cedente si fonda sul principio di corrispettività della prestazione lavorativa. Proprio alla stregua di tale principio, al di fuori delle eccezioni tassativamente previste dalla legge, il diritto alla retribuzione sorge soltanto quando la prestazione lavorativa sia stata effettivamente resa; in caso contrario, in capo al datore di lavoro sussiste soltanto un obbligo di risarcire il danno. Tuttavia, nell’ipotesi specifica di rifiuto illegittimo del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa regolarmente offerta, le Sezioni Unite – con un’interpretazione costituzionalmente orientata – hanno introdotto un superamento della regola sinallagmatica della corrispettività, in quanto una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe l’efficacia dei rimedi che l’orientamento appresta per il lavoratore.
In sintesi: il datore di lavoro che persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa, ritualmente offerta dopo l’accertamento giudiziale che ha rispristinato il vinculum iuris, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni. Pertanto, le Sezioni Unite con tale decisione, in riferimento all’interposizione illegittima di manodopera, hanno pronunciato il seguente principio di diritto: “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti dell’articolo 3-bis, D.Lgs. 276/2003, a decorrere dalla messa in mora”.
Secondo la Corte Costituzionale l’indirizzo interpretativo – indicato come diritto vivente – oggetto di verifica di legittimità costituzionale, è stato modificato da questo innovativo principio di diritto delle Sezioni Unite e, poiché tale pronuncia mira a ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della mora del creditore nel rapporto di lavoro, essa “consente di risolvere in via interpretativa i dubbi di costituzionalità prospettati”.
Pertanto, la Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme sulla mora credendi in riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117, comma 1, Costituzione, rimette alla Corte d’Appello di Roma la rivalutazione della questione interpretativa dibattuta nel giudizio principale, che investe il diritto del lavoratore ceduto, già retribuito dal cessionario, di rivendicare la retribuzione anche nei confronti del cedente.
Si evidenzia, tuttavia, che i giudici di merito, nel conformarsi al decisum della Corte Costituzionale – che a sua volta riprende l’iter argomentativo delle Sezioni Unite – dovranno prestare particolare attenzione a non soffermarsi a una lettura superficiale del principio di diritto sopra enunciato. Infatti, sebbene i giudici di legittimità attribuiscano natura retributiva all’obbligazione del datore di lavoro moroso, tuttavia tale principio non conduce affatto alla conseguenza della doppia retribuzione (quella dovuta dal cedente e quella percepita dal cessionario), come potrebbe apparire da una prima lettura. Le Sezioni Unite, invero, hanno applicato al caso loro sottoposto di interposizione fittizia di manodopera nell’appalto di servizi il disposto dell’articolo 27, comma 2, D.Lgs. 276/2003, dettato in tema di somministrazione irregolare e richiamato dell’articolo 29, comma 3-bis, che disciplina l’appalto illecito, secondo cui “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata”. Occorre, allora, comprendere se nella trasposizione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite per il caso dell’interposizione illecita al caso del trasferimento di ramo d’azienda dichiarato illegittimo debba essere mantenuto oppure no il corollario del carattere liberatorio – a favore del datore di lavoro cedente – del pagamento della retribuzione da parte del terzo cessionario. Ossia, se tale effetto liberatorio, enunciato espressamente dalla legge per lo specifico caso dell’interposizione illegittima, abbia valenza generale, ovvero carattere eccezionale, sì da non poter essere applicato in casi diversi da quelli espressamente previsti. Ebbene, seguendo il ragionamento logico-giuridico effettuato dai giudici di legittimità, è necessario sottolineare come questi ultimi hanno ricondotto il citato articolo 27, D.Lgs. 276/2003, ai principi del diritto comune, e in particolare alla disciplina dettata dall’articolo 1180, comma 1, e all’articolo 2036, comma 3, cod. civ., che regolano l’adempimento del terzo e l’indebito soggettivo, manifestando e ribadendo la portata dell’efficacia satisfattiva del pagamento del terzo. Con riferimento alla fattispecie in esame, nella cessione del ramo d’azienda si ha la sostituzione del cedente con il cessionario, pertanto il rapporto giuridico rimane inalterato nei suoi elementi oggettivi – salvo eccezione la cui prova deve essere fornita dalla parte interessata – quindi, una sola è la prestazione lavorativa che il lavoratore svolge nel ramo (illegittimamente) ceduto. Pertanto, il pagamento del cessionario costituisce un pagamento consapevole, effettuato da un soggetto che non è il vero creditore della prestazione e, dunque, un adempimento del terzo cui consegue la liberazione del vero obbligato, in applicazione dell’articolo 1180 cod. civ..
Di conseguenza, il lavoratore non potrà ottenere dal cedente la medesima retribuzione già corrispostagli dal cessionario, ma solo le differenze rispetto a quanto avrebbe percepito alle dipendenze del primo. Giova rilevare che, in tal senso, si sono pronunciate anche più recenti sentenze della Cassazione n. 14019/2018 e Cassazione n. 14136/2018 – che sono state richiamate proprio nella sentenza n. 29/2019 della Corte Costituzionale, quali espressioni del nuovo “diritto vivente” idoneo a far cadere i dubbi di costituzionalità sollevati dalla Corte d’Appello di Roma.
Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:



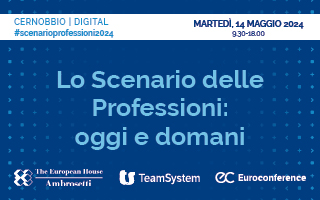




3 Maggio 2019 a 9:45
Salve,
relativamente alle conclusioni dell’articolo
“.. Di conseguenza, il lavoratore non potrà ottenere dal cedente la medesima retribuzione già corrispostagli dal cessionario, ma solo le differenze rispetto a quanto avrebbe percepito alle dipendenze del primo…”
Ne siete assolutamente certi, oppure è una vostra interpretazione?
Credo di aver capito che la Corte d’Appello di Napoli, con la recentissima sentenza 2423/19, si sia espressa in maniera differente, garantendo l’intera retribuzione, indipendentemente da quanto percepito da terzi.
Cordiali Saluti
Carmine
14 Maggio 2019 a 10:45
Gentile lettore,
in riferimento al primo quesito sottopostoci, le conclusioni dell’articolo qui in commento rappresentano una interpretazione derivante dal ragionamento logico – giuridico sviluppato dalla Corte Costituzionale, che, a sua volta, ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 2990 del 2019.
Per quanto riguarda il secondo quesito, non siamo riusciti a reperire la sentenza da Lei citata della Corte di Appello n. 2423/2019. Tuttavia, è possibile che il giudice di merito si sia volontariamente discostato delle precedenti decisioni giudiziali, poiché – a differenza dei paesi di common law – non esiste alcun vincolo giuridico che impone ai giudici di conformarsi alle precedenti sentenze sul medesimo tema. Ciò detto, se riuscisse a farci avere una copia della sentenza sarebbe sicuramente interessante poterla esaminare.
Cordiali saluti