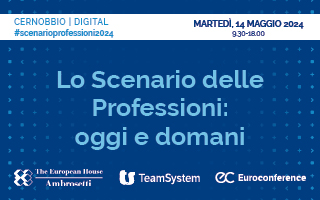L’articolo 15, St. Lav., e le discriminazioni sul posto di lavoro
di Evangelista BasileRosibetti Rubino
L’articolo 15, St. Lav., ha fissato un principio fondamentale del nostro ordinamento: il divieto di discriminazione sui luoghi di lavoro. Tale principio, già affermato in ambito internazionale ed europeo, ha visto negli anni un rafforzamento, sia in termini qualitativi che quantitativi, per il tramite della giurisprudenza, di ulteriori Leggi nazionali e – non da ultimo – del diritto comunitario. Ad oggi, dunque, il divieto di discriminazione è sì principio consolidato, ma ancora destinato a implementarsi ed estendersi man mano che la società vive nuove e differenti forme di discriminazione che il sistema si prefigge di abbattere.
La nascita e l’evoluzione del principio di non discriminazione
Il principio di non discriminazione trova il suo primo riconoscimento a livello internazionale: è il primissimo secondo dopoguerra e, in quell’ondata di decisa riaffermazione dello Stato di diritto nata in seguito alla sconfitta dei totalitarismi, la Carta delle Nazioni Unite (ovvero l’accordo istitutivo dell’Onu), sottoscritta a San Francisco il 26 giugno 1945, all’articolo 1, paragrafo 3, stabilisce tra i principi della nascente organizzazione internazionale la promozione “dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione”.
Il riconoscimento dei diritti dell’uomo ha, poi, compiuto un ulteriore importante passo avanti a livello internazionale qualche tempo dopo, con la sottoscrizione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, firmata a Parigi nel 1948. In particolare, all’articolo 2 veniva sancito che “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità”, mentre all’articolo 7 si affermava che “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”.
In soli 3 anni, dunque, la comunità internazionale aveva già ben presente la necessità di ampliare l’elenco delle possibili cause di discriminazione e di riconoscerne una tutela giurisdizionale.
La Dichiarazione – definita come “la Magna Charta dell’umanità” da Eleanor Roosevelt – nonostante non sia tecnicamente né un trattato né una convenzione, e quindi non porrebbe in essere norme giuridicamente obbligatorie, ha comunque trovato un suo importante spazio nel diritto internazionale, come (fondamentale) proclamazione di principio divenuto diritto cogente quale norma consuetudinaria.
Le disquisizioni tecniche, per quel che riguarda il nostro Paese, vengono in ogni caso messe a tacere nel 1950, con l’adozione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la quale, invece, ha valenza obbligatoria. L’importanza della CEDU risiede soprattutto nell’introduzione di un meccanismo giurisdizionale per la tutela dei diritti attraverso il ricorso alla Corte di Strasburgo. L’articolo 14, CEDU, dispone che “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione”.
La Corte – per il tramite del suddetto articolo 14 – ha sempre considerato tale elenco non tassativo e ampliato, quindi, l’ambito di applicazione di ogni singolo diritto dei cittadini. Ciononostante, più che tutelare un autonomo diritto di uguaglianza, la CEDU ha in realtà introdotto una tutela nell’egual godimento degli altri diritti previsti (e in questo senso è differente dal principio di uguaglianza dichiarato dalle Carte costituzionali europee, fra cui quella italiana).
Per entrare poi più nell’ambito giuslavoristico, il percorso del principio di non discriminazione continua con la convenzione OIL n. 111/1958. L’articolo 1, convenzione, afferma che il termine discriminazione comprende “ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, la discendenza nazionale o l’origine sociale, che ha per effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d’impiego o di professione” e, in generale, “ogni altra distinzione, esclusioni o preferenza che abbia per effetto di negare o di alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d’impiego o di professione”.
In ambito europeo, tracce di questi principi sono, invece, rinvenibili nella Carta di Nizza del 2000 (la Carta dei diritti fondamentali dell’UE) nonché in alcuni articoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue) del 2008. In particolare, la prima stabilisce il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale (articolo 21). Mentre, il Tfue – all’articolo 10 – stabilisce che “Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale” e all’articolo 19 che “fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”.
Sebbene tale ultima norma non abbia offerto una tutela diretta ai cittadini europei, è proprio sulla base dell’articolo 19 che hanno trovato le fondamenta i successivi interventi normativi in materia. Proprio in attuazione dell’articolo 19, Tfue, sono, infatti, state emanate le successive Direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2002/73/CE.
Significativa e nota per lo scenario giuslavoristico è proprio la seconda, la c.d. Direttiva quadro, relativa all’ambito della tutela contro le discriminazioni nel settore del diritto del lavoro, il cui articolo 1 “mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento”.
Occorre rilevare, inoltre, che è alla giurisprudenza comunitaria – sempre nel percorso di ampliamento delle tutele – che dobbiamo la classificazione delle discriminazioni dirette e indirette. Per ragioni di sinteticità, basti qui ricordare che per discriminazione c.d. diretta la legislazione comunitaria intende qualsiasi situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente – ad esempio, sulla base del genere o della razza – di quanto sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in una situazione analoga (Direttiva 2006/54); mentre nella nozione di discriminazione c.d. indiretta rientra ogni atto o comportamento – un criterio o una prassi uguale per tutti e, quindi, tendenzialmente “neutra” – che colpisce in modo più sfavorevole alcune persone rispetto ad altre nella stessa situazione, per uno dei motivi per cui è vietato discriminare.
Ripercorso così lo scenario internazionale ed europeo, possiamo restringere la nostra indagine al territorio nazionale, che è stato e inevitabilmente sarà – come vedremo – comunque influenzato dalle norme sovranazionali.
Nell’esperienza italiana, il primo riconoscimento del principio di uguaglianza e quindi, de relato, del divieto di discriminazione risale al 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione, agli articoli 2 – “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e chiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” – e 3 – “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
È così che la tutela antidiscriminatoria trova spazio nel nostro Paese, sia sotto il profilo “diretto” – che nella nostra Carta è teorizzato quale principio di uguaglianza formale (articolo 3, comma 1) –, sia sotto il profilo “indiretto”, quale uguaglianza sostanziale (articolo 3, comma 2).
Sulla base delle norme costituzionali, il divieto di discriminazione viene poi richiamato, specificato e ampliato in numerose ulteriori norme. Si pensi, ad esempio, all’articolo 1, L. 300/1970, con riferimento alle opinioni religiose e alle convinzioni personali; agli articoli 15 (di cui parleremo più approfonditamente infra) e 16 della stessa Legge, con riguardo alle tutele contro i trattamenti discriminatori relativi alle assunzioni, ai licenziamenti, ai demansionamenti, alle assegnazioni professionali dettati da motivi religiosi. E così, ancora, possiamo ricordare l’articolo 10, D.Lgs. 276/2003, che ha posto il divieto per le agenzie per il lavoro e per gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati “di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base […] al credo religioso”; mentre è toccato ai D.Lgs. 215/2003 e 216/2003 – attuativi dell’importante Direttiva quadro sopra citata – introdurre il principio di parità di trattamento fra le persone, indipendentemente da religione e convinzioni personali per quanto concerne i soli ambiti dell’occupazione e delle condizioni di lavoro, nonché la tutela rispetto alle discriminazioni dirette, indirette e alle molestie basate sull’orientamento religioso, le opinioni personali, l’handicap, l’età e l’orientamento sessuale dei lavoratori. Il successivo D.Lgs. 145/2005 ha, poi, incluso le molestie di genere e le molestie sessuali come fattispecie discriminatoria, oltre che tutti quei trattamenti sfavorevoli che vengono adottati dal datore di lavoro come ritorsione verso chi abbia avanzato un reclamo o compiuto un’azione per pretendere il rispetto del principio di parità. L’articolo 27, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 198/2006), ha, invece, riassettato le disposizioni delle L. 903/1977 e 125/1991, vietando qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.
A completare il quadro, degna di nota è l’evoluzione delle tutele in tema di licenziamento discriminatorio: tale recesso è nullo ed è rimasto tale anche in seguito alle riforme del lavoro attuate con la L. 92/2012 (Legge Fornero), prima, e il D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti), poi, che, richiamando le norme sopracitate, fra cui l’articolo 15, St. Lav., hanno previsto una tutela reale piena in presenza di licenziamento discriminatorio legato a motivi politici, religiosi, sindacali, razziali, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basati sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.
L’articolo 15, L. 300/1970
L’introduzione dello Statuto dei Lavoratori ha avuto l’indiscusso merito di portare i diritti fondamentali sanciti nella nostra Carta costituzionale nei luoghi di lavoro. Il principio di non discriminazione è, come abbiamo visto, essenziale per concretizzare e attuare a pieno il principio – costituzionalmente garantito – di uguaglianza.
In questo senso, l’articolo 15, St. Lav., è perciò espressione dell’uguaglianza nei posti di lavoro. Nella sua versione originale, la norma aveva una portata più ristretta di quella odierna e prevedeva: “È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa”.
Una prima modifica della norma fu attuata ad opera della L. 903/1977, il cui articolo 13 sostituì il secondo comma dell’articolo 15 con il seguente: “Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso”.
Infine, il D.Lgs. 216/2003 ha reso la norma quella che conosciamo oggi, incidendo ulteriormente sul medesimo comma, che ad oggi prevede: “Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali”.
Come è evidente, quindi, l’articolo 15, St. Lav., ha seguito l’evoluzione legislativa sopra descritta, ampliando costantemente le possibili cause di discriminazione. L’evoluzione della disciplina antidiscriminatoria indica che si è partiti dall’unica libertà di pensiero, già costituzionalmente tutelata dall’articolo 21, passando per la garanzia della libertà costituzionale di cui all’articolo 39, comma 1, per giungere alla libertà di pensiero politico e religioso e, infine, sotto l’impulso europeo, alla libertà di convinzioni personali (ex articolo 1, D.Lgs. 216/2003) nonché ai divieti di discriminazione per razza, lingua, sesso, handicap, età (caratteristiche, queste ultime, quasi del tutto indipendenti dalla stessa volontà dell’individuo).
Il privato datore di lavoro, dunque, è tenuto non tanto a praticare la parità di trattamento verso i suoi dipendenti, bensì a rispettare il principio di non discriminazione, cioè a non praticare disparità di trattamento in ragione di fattori che la Legge gli vieta di prendere in considerazione.
In detto quadro, l’articolo 15 si configura quale vera e propria norma di chiusura (qualsiasi atto o patto diretto a recare altrimenti pregiudizio), si sostanzia, cioè, in una formula così ampia, da ricomprendere nel divieto anche le discriminazioni atipiche, ovvero quelle non direttamente tipizzate dal Legislatore. La norma, infatti, abbraccia non solo le discriminazioni che comportino disparità di trattamento in senso comparativo rispetto agli altri lavoratori, ma tutti gli atti o patti che possano recare pregiudizio a motivo di un fattore illecito. Nel processo di allargamento della tutela di cui si è detto, il Legislatore ha così incluso nella nozione di discriminazione anche quelle condotte o comportamenti idonei a recare pregiudizio, a prescindere dalla loro intenzionalità soggettiva.
L’ampiezza dell’articolo 15 – sulla scorta delle ampie definizioni comunitarie – ha quindi permesso alla giurisprudenza di allargare e di aggiornare le fattispecie discriminatorie.
A riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si ricordi il caso, venuto alla ribalta sulla stampa nazionale, di una cittadina italiana figlia di genitori egiziani e di religione musulmana che aveva fatto ricorso al Tribunale di Lodi, affinché venisse accertata la discriminazione per motivi religiosi presuntivamente subita, poiché le era stato chiesto di togliere il velo; e, in seguito al suo rifiuto, era stata esclusa dalla procedura di selezione per la posizione di hostess per mansioni di volantinaggio. La società convenuta si era difesa affermando che l’attività prevedeva il diretto contatto con il pubblico ed erano richieste determinate caratteristiche (tra cui l’obbligo di indossare una divisa che non prevedeva la copertura dei capelli), per cui l’unico motivo dell’esclusione sarebbe stato l’indisponibilità della ragazza a togliere il velo e non la sua religione di appartenenza. Il Tribunale lodigiano, con l’ordinanza del 3 luglio 2014, aveva accolto la tesi datoriale, non ritenendo che l’esclusione fosse avvenuta poiché musulmana, ma a contrario trovava ragione nella legittima richiesta di non indossare un copricapo, qualunque esso fosse, durante la prestazione lavorativa.
La Corte d’Appello di Milano, invece, con la sentenza del 4 maggio 2016, aveva ribaltato la decisione del Tribunale, accogliendo il ricorso della giovane musulmana. Secondo la Corte di Milano, infatti, l’insussistenza della volontà di discriminare della società non era rilevante ai fini dell’accertamento della discriminazione (che abbiamo visto essere indipendente da una condizione soggettiva dell’autore dell’atto discriminatorio) e, essendo il velo connotazione esteriore tipica della religione musulmana, l’esclusione da un posto di lavoro a causa di questo costituiva una discriminazione diretta in ragione dell’appartenenza religiosa, mentre, dall’altra parte, non era emerso in alcun modo che il capo scoperto fosse requisito essenziale e determinante della prestazione lavorativa.
Tuttavia, a livello europeo, sullo stesso tema, le sentenze C-157/15 e C-188/15 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno condotto a scenari ed esiti differenti. La Corte ha, infatti, specificato che, qualora vi sia una norma aziendale che vieti espressamente l’utilizzo del velo sul posto di lavoro, il datore di lavoro può chiedere che lo stesso non venga indossato, non costituendo tale richiesta un trattamento discriminatorio, a condizione che:
- la differenza di trattamento non integri discriminazione indiretta, perché oggettivamente giustificata da un obiettivo legittimo perseguito dall’impresa che adotti una politica di neutralità nei confronti della clientela;
- i mezzi impiegati per il suo conseguimento risultino appropriati e necessari.
D’altro canto, tali pronunce si inseriscono nel solco di quel bilanciamento di interessi di cui bisogna sempre tener conto e, in particolare, nel caso dei datori di lavoro, con quel diritto di libertà di iniziativa economica loro spettante tutelato tanto a livello europeo (articolo 16, Carta di Nizza) quanto a livello nazionale dall’articolo 41, Costituzione.
Conclusioni
L’articolo 15, St. Lav., la cui formulazione odierna è quindi frutto di un’intensa evoluzione sociale prima ancora che giuridica, è ancora oggi del tutto attuale. Anzi, in tutta probabilità, tale norma antidiscriminatoria troverà sempre più applicazione pratica.
La sempre maggiore importanza dei diritti fondamentali dell’uomo, che man mano trovano ampliamento e riconoscimento all’interno degli ordinamenti nazionali e sovranazionali, e l’incremento della complessità della società e delle comunità che la compongono condurranno inevitabilmente a un costante aggiornamento di queste norme, al fine di tutelare un numero più ampio possibile di fattispecie passibili di essere dichiarate discriminatorie.
La forza cogente dell’articolo 15 sta proprio in questa sua capacità di auto aggiornarsi, di non essere ingabbiato dall’interpretazione strettamente letterale delle norme e di permettere, dunque, già ora, la tutela dei diritti dell’uomo (e della donna e di qualunque altro genere in cui ci si senta più rappresentati), senza necessità di interventi legislativi, spesso piegati alle tendenze ideologiche del momento e alla propaganda politica.
Ancora una volta, dunque, lo Statuto, a 50 anni dalla sua emanazione, si dimostra per quello che è: una Legge ben fatta, capace di evolvere e di adattarsi, continuando a perseguire lo scopo per cui è nato, la tutela dei diritti dei lavoratori e, nel caso dell’articolo 15, del principio di uguaglianza, formale e sostanziale, sui posti di lavoro.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Il giurista del lavoro“.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: