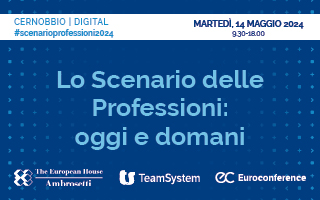Licenziamento orale e distribuzione degli oneri probatori
di Vittorio Matto
Quale onere probatorio grava sul prestatore di lavoro che impugni un licenziamento deducendone la nullità, in quanto irrogato senza il rispetto della forma scritta?
Partendo dalla considerazione giuridico-fattuale che non ogni cessazione del rapporto di lavoro è automaticamente un licenziamento, la Suprema Corte, con la sentenza n. 18402/2019, si è nuovamente espressa sul tema della distribuzione degli oneri probatori nella particolare fattispecie del licenziamento orale.
La pronuncia della Suprema Corte
La fattispecie in esame ha riguardato il caso sollevato da un datore di lavoro, il quali lamentava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 cod. civ., da parte della Corte d’Appello di Genova, specificamente laddove quest’ultima, una volta affermato che “la c.d. estromissione del lavoratore dal posto di lavoro inverte l’onere probatorio, ponendo a carico del datore l’onere di provare un fatto estintivo del rapporto diverso dal licenziamento”, concludeva che “per il lavoratore è sufficiente dimostrare l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro mentre è onere del datore di lavoro dimostrare che il rapporto è venuto meno per ragioni diverse“.
La conseguenza ultima, partendo dall’assunto che la società non aveva in alcun modo dimostrato che il rapporto fosse cessato per ragioni diverse dal licenziamento, era l’accertamento della sussistenza di un licenziamento orale, con i gravosissimi effetti sanzionatori della reintegrazione e del pagamento di tutte le retribuzioni maturate medio tempore.
La Suprema Corte, riprendendo un proprio recentissimo orientamento, sviluppato fra il 2018 e il 2019, ha fatto propria l’argomentazione del datore di lavoro ricorrente, secondo il quale “l’inversione dell’onere probatorio non può trovare applicazione, laddove il lavoratore si faccia carico di dare la prova del licenziamento orale e la prova non dia esito positivo”.
Pertanto, qualora le prove dedotte dal prestatore di lavoro – nella fattispecie 2 testimoni – non siano in grado di confermare che il medesimo era stato licenziato oralmente, l’inversione dell’onere della prova non può valere, laddove la prova fallisca, tanto più ove il prestatore di lavoro abbia addotto l’esistenza di precise circostanze, e in particolare dell’esistenza di testimoni presenti al licenziamento.
Tutto ciò fornisce anche l’occasione per svolgere alcune riflessioni riguardanti la questione della ripartizione degli oneri probatori in tema di licenziamento orale, oggetto di dibattito all’interno della giurisprudenza di legittimità, tanto da dare vita anche a letture divergenti di vicende processuali contigue.
La “cessazione” del rapporto di lavoro: vizi del licenziamento e sanzioni
Anche in un contesto come quello in esame, apparentemente circoscritto e lineare, esistono alcune variabili, specificamente con riferimento all’entità dell’onere probatorio gravante sul prestatore di lavoro.
Innanzitutto, una premessa d’ordine definitorio e concettuale, che, implicitamente, pare essere perfettamente nota alla Suprema Corte: parlando di cessazione degli effetti di un contratto di lavoro è necessario rilevare che, dal punto di vista strutturale, il licenziamento si configura quale atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso.
Conseguentemente, chi impugna il licenziamento deducendo che il medesimo si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta, ha l’onere di provare, ovviamente, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nonché il fatto stesso costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, sia essa realizzata mediante una formale comunicazione di risoluzione del rapporto o con comportamenti concludenti.
Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, e il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall’articolo 2697, comma 1, cod. civ., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, seppur “attenuato” in virtù del diverso peso delle parti. Non deve dimenticarsi, infatti, come la dinamica sottesa all’accertamento della legittimità del licenziamento preveda automaticamente una vera e propria inversione dell’onere della prova, atteso che è il datore di lavoro a dover dimostrare la legittimità del licenziamento, non il prestatore di lavoro che pure “eccepisce” la sua invalidità.
Qual è, dunque, il fondamento fattuale minimo, la cui sussistenza deve essere allegata e dimostrata dal prestatore di lavoro, della richiesta azionata da quest’ultimo di veder accertata l’illegittimità del recesso operato dal datore di lavoro?
Il licenziamento.
Sembra cosa ovvia, ma così può non essere.
Sul punto, la Cassazione precisa come non trovi riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell’intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l’estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe un’inversione dell’onere probatorio non prevista dall’ordinamento e neppure dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l’onere di provare che il licenziamento sia giustificato (articolo 5, L. 604/1966), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile a una volontà datoriale, cosa che, sia da un punto di vista logico che giuridico, sarebbe priva di senso. In proposito, infatti, la Suprema Corte rileva come una siffatta inversione dell’onere probatorio, anche volendo in ipotesi “superare” il tenore letterale della norma di riferimento, non sarebbe evincibile neanche in via sistematica: anche da questo eventuale punto d’osservazione si osserva come, sia la ricostruzione della volontà di licenziare, sia eventuali difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore, trovino adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni affidato al prudente apprezzamento del giudice.
Ciò considerato in merito al requisito fattuale minimo – il licenziamento – come noto l’ordinamento ha previsto la sanzione massima per il licenziamento orale, ossia la sua inefficacia, con conseguente diritto del prestatore di lavoro a essere reintegrato e a vedersi corrispondere tutte le retribuzioni dal momento del licenziamento: il rapporto di lavoro, infatti, non si sarebbe mai interrotto.
Una così grave sanzione trova certamente una sua ragione logico-giuridica nell’eccezionalità della modalità risolutiva del rapporto, ma rappresenta ormai una rarità nel nostro ordinamento giuslavoristico.
Difatti, limitando la valutazione alle disposizioni che valgono per i dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti nella sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo al quale era addetto il lavoratore licenziato, o con più di 15 dipendenti nello stesso Comune o, comunque, con più di 60 dipendenti, si osserva come non sia così frequente la previsione della sanzione reintegratoria in caso di licenziamento illegittimo, quale effetto degli interventi legislativi del 2012 e 2015.
In conclusione, esistono solo 2 modalità di licenziamento, che, ove sussistenti, danno automaticamente accesso alla sanzione più grave, ossia la reintegrazione, addirittura a prescindere dal numero di dipendenti assunti: da un lato, la categoria dei licenziamenti discriminatori/ritorsivi, dall’altro, il licenziamento intimato oralmente.
Ma, mutuando un noto proverbio, fra la teoria e la pratica c’è di mezzo il “mare” della distribuzione degli oneri probatori.
Licenziamento orale: la prova della cessazione del rapporto riconducibile alla volontà datoriale
Infatti, se pure è vero che la sanzione per il licenziamento orale è la più pesante (per il datore di lavoro), paradossalmente il prestatore di lavoro potrebbe incontrare non poche difficoltà probatorie per far valere il proprio diritto.
Facciamo un passo indietro.
Il puro e semplice “evento” della cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé idoneo a fornire prova univoca del licenziamento: si tratta, in realtà, di circostanza di fatto di significato ambivalente, potendo essere la conseguenza sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. La Suprema Corte, seppur implicitamente, si sofferma proprio su significato e origine della cessazione del rapporto di lavoro e consente all’interprete di rilevare come non necessariamente l’allontanamento dall’attività lavorativa sia effetto della volontà del datore di lavoro di esercitare il potere di recesso risolvendo il rapporto. Come noto, l’accertata cessazione nell’esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice di merito può radicare il proprio convincimento in merito alla fonte giuridica della medesima cessazione, ossia che il lavoratore abbia assolto l’onere probatorio sullo stesso gravante circa l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro a iniziativa del datore.
Il tema dell’onere probatorio diventa, dunque, particolarmente rilevante, soprattutto in specifiche situazioni, nelle quali non esiste un indubbio e inequivoco atto di cessazione del rapporto.
Certamente, qualora il datore di lavoro deduca che un rapporto di lavoro si è estinto per le dimissioni del lavoratore, sia in via d’azione che d’eccezione, il medesimo datore è sottoposto all’onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda o dell’eccezione: in entrambi i casi la prova della volontà dismissiva (o del comportamento concludente) del lavoratore dovrà essere rigorosamente vagliata e, al netto degli eventuali vincoli di forma per l’atto dismissivo, la verifica del significato di una dichiarazione o di un comportamento del lavoratore cui si attribuisca la valenza di recesso dovrà essere condotto alla luce delle circostanze in cui la risoluzione si è verificata, delle condizioni di interesse di ciascuna delle parti alla prosecuzione del rapporto ovvero alla sua estinzione, delle diversità di poteri e di facoltà attribuiti ai contraenti nel rapporto di lavoro.
D’altro canto, laddove il licenziamento sia impugnato come orale e il datore opponga, invece, che il rapporto si è estinto per le dimissioni del dipendente, il giudice sarà chiamato a indagine, innanzitutto fattuale, volta a verificare la qualificazione giuridica della fattispecie, allo scopo di inquadrarla, quindi, nell’alveo del licenziamento oppure in quello delle dimissioni. In questo ambito si muove, come visto sopra, la pronuncia in esame, che, in modo del tutto lineare e ragionevole, schematizza in modo chiaro e sintetico i rispettivi oneri probatori del prestatore di lavoro, gravato del fondamentale onere di provare in modo inequivoco che la cessazione del rapporto di lavoro sia stata originata dalla manifestazione della volontà del datore di lavoro, e di quest’ultimo, il quale potrebbe anche limitarsi a eccepire semplicemente che la cessazione del rapporto è dipesa da dimissioni rassegnate (seppur per fatti concludenti, quale, ad esempio, l’allontanamento dal posto di lavoro) dal prestatore di lavoro.
Peraltro, non può trascurarsi che l’orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte ha visto la contrapposizione del diverso assunto secondo il quale nel sistema di regolazione dei licenziamenti individuali “il fatto costitutivo del diritto alla riassunzione e poi alla reintegrazione, secondo le variazioni della l. n. 300 del 1970, è un fatto – il licenziamento appunto – attribuibile alla sola iniziativa del datore di lavoro, alla quale non corrisponde una identica iniziativa del lavoratore”, con l’effetto che la prova gravante sul lavoratore che domandi la reintegrazione nel posto di lavoro sarebbe semplicemente quella della “estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione di un fatto che nega il licenziamento e collega la estromissione dal rapporto ad asserite dimissioni del lavoratore assume la valenza di una eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c.”.
Argomentava la Cassazione che “la valutazione dei possibili significati della prova deve essere compiuta quantomeno con specifica attenzione alla peculiarità delle facoltà attribuite ai contraenti e ai poteri attribuiti al datore di lavoro (…) in special modo l’indagine del giudice del merito deve essere rigorosa, data la gravità delle relative conseguenze in relazione a beni giuridici che formano oggetto di tutela privilegiata da parte dell’ordinamento, quando si tratti di stabilire il significato di una dichiarazione o di un comportamento cui si assegni valore negoziale di recesso del lavoratore (cosiddette dimissioni), in tal caso dovendosi stabilire, attraverso l’interpretazione dell’atto di recesso e la valutazione dei comportamenti in concreto osservati dal lavoratore, che da parte sua sia stata manifestata in modo univoco l’incondizionata volontà di porre fine al rapporto e che tale volontà sia stata idoneamente comunicata alla controparte”.
Proprio con riferimento a questo diverso orientamento, secondo cui è sufficiente per il lavoratore che impugna il licenziamento orale la prova della “cessazione” del rapporto lavorativo, la giurisprudenza di legittimità precisava che “la prova gravante sul lavoratore – che chieda giudizialmente la declaratoria di illegittimità dell’estinzione del rapporto – riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo cioè la estromissione del lavoratore dal luogo di lavoro”, atteso che il licenziamento “costituisce un atto unilaterale di recesso con cui una parte dichiara all’altra la sua volontà di estinguere il rapporto e che, quindi, non può che essere comprovato da chi abbia manifestato tale volontà di recedere, non potendo la parte (la quale abbia “subito” il recesso) provare una circostanza attinente alla sfera volitiva del recedente”, per cui “deve confermarsi che l’onere della prova del licenziamento grava sul datore di lavoro”.
In sostanza, si trattava di una giurisprudenza che, di fatto, pareva ritenere che ogni cessazione del rapporto di lavoro fosse fondamentalmente sussumibile in un licenziamento, con conseguente inversione dell’onere probatorio sul datore di lavoro. Ma non ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro consiste in un licenziamento.
In verità, la pronuncia in esame, unitamente ad altre recentissime sentenze (del 2018 e 2019) ivi richiamate, svolge un percorso logico-giuridico ragionevole e lineare, che:
- parte da un presupposto molto semplice in tema di onere probatorio, ossia che la mera cessazione nell’esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire la prova che “la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro”;
- prosegue riconoscendo una circostanza giuridica ovvia, ovvero che il prestatore di lavoro ha, quantomeno, l’onere di provare il fatto costitutivo della propria domanda, ossia che la risoluzione del rapporto di lavoro è effettivamente un licenziamento, cioè effettivamente ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti;
- per poi pervenire all’altrettanto ovvia (e inevitabile) conclusione che “la mera cessazione nell’esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova”;
- completando, infine, il principio di diritto enunciato, secondo il quale “Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa – anche avvalendosi dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c. – e solo nel caso perduri l’incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697 c.c., comma 1, rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa (Cass. n. 3822 del 2019; conf. Cass. n. 13195 del 2019; v. pure Cass. n. 31501 del 2018)”.
In conclusione, è interessante evidenziare la natura fondamentale che riveste il requisito dell’intimazione del recesso in forma scritta, funzionalmente orientato a garantire il lavoratore dal rischio di scelte poco ponderate del datore di lavoro, nonché ad essere posto nella situazione di sapere, in modo certo e univoco, che vi è stato un atto interruttivo del rapporto lavorativo, a conoscerne le relative ragioni nonché le tempistiche in cui lo stesso si è concretizzato.
Ai sensi dell’articolo 2, L. 604/1966, così come riformato dalla L. 92/2012, “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
Proprio a seguito di tale novella legislativa, il datore di lavoro deve specificare, già al momento della comunicazione del licenziamento, i motivi che lo hanno determinato; laddove precedentemente, invece, il prestatore di lavoro poteva chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che avevano determinato il recesso, dovendo, in tal caso, il datore di lavoro comunicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta. Peraltro, anche questa dichiarata “inefficacia” è, in realtà, un’illegittimità, in quanto, fatti salvi i casi circoscritti che prevedono la reintegrazione del rapporto di lavoro, non comporta la ricostituzione del rapporto di lavoro, quanto una conseguenza “sanzionatoria” di tipo economico.
Resta, infine, una sorta di paradosso per il caso del licenziamento orale: pur andando incontro alla sanzione più grave, ossia la reintegrazione e il pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, il dipendente corre il rischio di non essere in grado di far valere il proprio diritto, essendo (ragionevolmente) gravato da un onere probatorio che riguarda un atto – il licenziamento – che formalmente non esiste. In realtà, se in punto di diritto può ben considerarsi corretto l’orientamento della Suprema Corte, è pur vero che, nell’ipotesi in cui il prestatore di lavoro receda dal rapporto per fatti concludenti (definitivo allontanamento dal posto di lavoro), un datore di lavoro previdente e cauto dovrebbe contestare la condotta come disciplinarmente rilevante e procedere poi con un vero e proprio licenziamento disciplinare.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: