Licenziamento e profitto sono conciliabili?
di Evangelista Basile
Per lungo tempo siamo stati abituati a pensare che – almeno in termini giuslavoristici – le parole “profitto” e “licenziamento” non fossero conciliabili, soprattutto in tema di licenziamento per ragioni oggettive o economiche. In effetti, quest’abitudine di pensiero si è radicata nel tempo in virtù di una giurisprudenza abbastanza allineata nel ritenere illegittimo il licenziamento per gmo, allorché non sorretto – a monte – da una situazione di grave e profonda crisi economico-finanziaria dell’impresa. Le tante pronunce che hanno nel tempo contribuito a declinare il “giustificato motivo oggettivo” di licenziamento – coincidente con la soppressione del posto di lavoro – non si limitavano a sostenere la necessità di una situazione di andamento negativo dell’azienda, ma imponevano la prova – ai fini della legittimità del recesso – della crisi non congiunturale, attestante un sovradimensionamento strutturale dell’organico.
Ora, è evidente a chiunque che la prova certa della crisi strutturale si ha solo nei casi prossimi al fallimento, perché una qualche speranza di uscire da una situazione economica difficile ce l’hanno tutti gli imprenditori, prima di fallire. E, tuttavia, chi frequenta i mercati concorrenziali – aperti al libero mercato e alle sfide globali – sa perfettamente che il ritardo nel ridimensionamento dell’organico porta a disperdere risorse, limitare gli investimenti e, infine, perdere opportunità di crescita ed essere sconfitti: in una parola, alla chiusura.
Portabandiera di tale orientamento era la massima, spesso e stancamente ripetuta dalla giurisprudenza, secondo cui il licenziamento per gmo doveva essere determinato dall’esigenza di procedere alla soppressione del posto cui è addetto il singolo lavoratore, “soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti” (cfr. Cass., sez. Lav., 2 ottobre 2006, n. 21282).
Tuttavia, in tema di licenziamenti, la legge non ha mai affermato la necessità della crisi o anche solo della prova di una situazione economica negativa per motivare il recesso per gmo. Del resto, basta leggere la disciplina di riferimento per rendersene conto: il licenziamento è ammesso in presenza di concrete “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (articolo 3, L. 604/1966).
Nel “riscoprire” il citato dettato normativo, la giurisprudenza ha incominciato ad estendere la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo alle ipotesi di riorganizzazione non strettamente collegate a crisi o situazioni economiche sfavorevoli, purché vi fosse la prova certa della soppressione del posto di lavoro e l’impossibilità di ricollocare utilmente il dipendente (esternalizzazioni, redistribuzioni di mansioni, etc.). Da ultimo, poi – ed è qui la novità più importante che si commenta – i giudici del lavoro hanno ammesso la possibilità di licenziare anche al fine di raggiungere un maggior profitto. È stata la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13516/2016 ad affermare la conciliabilità del licenziamento col profitto, con una motivazione per nulla superficiale, anzi diffusa e convincente. La Suprema Corte ha chiarito che – se il licenziamento consente la contrazione dei costi – è irrilevante che tale contrazione sia rivolta a prevenire perdite di esercizio o, piuttosto, a procurare al datore di lavoro un incremento di profitto. Infatti, in generale, la ratio del licenziamento per gmo risiede nella più efficiente organizzazione economica, ovvero nella migliore produttività. Partendo dunque da una nozione di produttività intesa come il rapporto tra la quantità di prodotto (o di servizi) ottenuta in un certo periodo di tempo e la quantità dei fattori produttivi impiegati nel medesimo arco temporale e processo produttivo (i costi), la Suprema Corte – attraverso un ragionamento logico-matematico difficilmente contestabile – è giunta alla conclusione che “ogni incremento di produttività si traduce sempre anche in un risparmio o contrazione dei costi”.
Tale nuovo orientamento consente anche di rispettare il dettato normativo dell’articolo 30, L. 183/2010, spesso dimenticato, secondo cui “In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge … contengono clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente”.
Distogliere l’indagine dal fine ultimo della soppressione del posto – se per far fronte a una crisi o incrementare i profitti – evita al giudice del lavoro di sindacare nel merito le scelte dell’impresa.
Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:



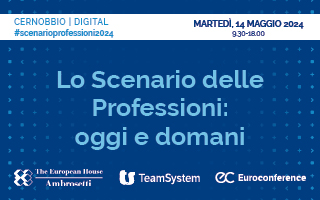




22 Novembre 2016 a 19:00
Come sempre l’avvocato Basile è molto chiaro e rende “semplice” l’esposizione dei fatti e dei contenuti di una sentenza della Corte di Cassazione. Finalmente un cambio di direzione molto importante. Ricordo un passaggio del prof. Ichino, in un’intervista proprio sui licenziamenti, che diceva: la nostra giurisprudenza induce gli imprenditori al fallimento prima di poter licenziare per gmo. Speriamo che il vento sia veramente cambiato e questa sentenza della Suprema Corte è più di una speranza.
Grazie avv. Basile