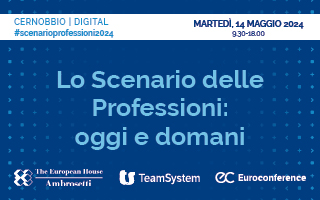Prassi aziendale: riflessi su premialità e vicende aziendali
di Andrea Ercoli
Nello svolgimento del rapporto non è infrequente, per il datore di lavoro, incontrare difficoltà nella gestione delle prassi aziendali, stratificate nel corso di anni di vita dell’azienda. La natura intrinsecamente non scritta né formale dell’uso aziendale, infatti, ne sfuma i confini e rende di difficile individuazione il perimetro degli obblighi nascenti dalla medesima prassi. Se ciò è senz’altro vero per quanto riguarda i comportamenti e le condotte dei lavoratori nello svolgimento della propria prestazione lavorativa, l’incertezza si riduce sensibilmente se oggetto dell’uso è un riconoscimento premiale da riconoscersi al lavoratore, in qualsiasi forma si sostanzi l’erogazione. Ecco che il datore di lavoro si trova obbligato (stante ovviamente tutto quanto diremo oltre in tema di eccezioni), a fronte dell’uso, a riconoscere alcuni emolumenti ai propri dipendenti, derivanti da un comportamento tenuto nel corso di una lunghissima vita aziendale, di cui potrebbe essere stato attore nel solo ultimo periodo. Percorrendo la medesima linea di ragionamento a ritroso, sensibile è anche il tema del riconoscimento della prassi aziendale al fine di conferirgli tale status: quando ci si trova di fronte a un uso? Quali strumenti ricognitivi esistono relativamente a questo tema?
Premessa
Il caso da cui questo contributo prende le mosse è emblematico sotto numerosi punti di vista: prassi aziendale pluridecennale, premialità, contratto aziendale che supera la prassi, riconoscimento del premio sottoforma di un bene e non di valuta, vicende di trasferimento aziendale. La fattispecie è contenuta in quanto analizzato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2927/2019. Del caso si darà breve riassunto nel prosieguo del ragionamento, con alcuni cenni a quanto è stato ricostruito in senso generale sul tema dell’uso aziendale da parte della giurisprudenza. Trattandosi di argomenti che si inseriscono nella macro-tematica delle fonti del diritto, alcune delle conclusioni tratte sul tema discendono da un dibattito di natura eminentemente teorica, ma la rilevanza di tali conclusioni ha ricadute di natura assolutamente pratica e quotidiana.
Il caso
La Corte di Cassazione Civile, con ordinanza n. 2927/2019, è chiamata a valutare la legittimità della decisione della Corte d’Appello di Torino, nella quale si approfondisce il tema della prassi aziendale e della sopravvivenza della stessa in conseguenza di vicende aziendali. La vicenda riguarda un lavoratore dipendente che lamenta, nei confronti della società datrice di lavoro, la mancata consegna di un orologio di pregio (nella sentenza si fa riferimento a un preciso marchio) al compimento del trentesimo anno di servizio presso la medesima realtà aziendale. Tale riconoscimento sarebbe stato frutto di una prassi diffusa in tutte le aziende facenti parte del gruppo da molti anni.
Il lavoratore, inizialmente, risultava assunto da una società di rilevanti dimensioni che – successivamente – faceva transitare senza soluzione di continuità il rapporto di lavoro presso una società “figlia”, interamente controllata. A seguito di ciò, la società “figlia” veniva ceduta (mediante cessione dell’intero pacchetto azionario) ad altra compagine, che pertanto subentrava alla guida della stessa. Tale ultima cessione avveniva nell’anno 2002.
In data 5 giugno 2008, a seguito dei citati passaggi, veniva concluso un contratto integrativo aziendale, con il quale si istituiva un premio legato all’anzianità di servizio. L’articolo istitutivo del premio aveva il seguente tenore: “le parti […] hanno convenuto di istituire un apposito premio che con decorrenza primo luglio 2008 verrà erogato a tutti i dipendenti […] in cui avranno maturato i venti, venticinque, trenta, trentacinque anni di anzianità aziendale. Inoltre, nel caso di dimissioni per pensionamento, ai lavoratori con almeno trent’anni di anzianità aziendale, con le spettanze di fine rapporto verrà erogato ulteriore premio di importo pari a € 4000 lordi […] le parti si danno inoltre atto che il premio esperienza, come precedentemente definito, risulta nel complesso migliorativo rispetto qualsiasi trattamento o uso analogo applicato […] con particolare riguardo quanto previsto in materia di orologio, premio anzianità e fedeltà, che pertanto sono integralmente assorbiti e sostituiti”.
Il lavoratore risulta assunto presso la prima delle aziende a far data dal 19 maggio 1978. Alla richiesta dell’orologio da parte dello stesso, l’azienda oppone il contratto integrativo, nonché la cessazione dell’uso aziendale dettata dalla cessione della società ad altro gruppo, asserendo – peraltro – che l’ultimo orologio era stato consegnato in precedenza alla cessione del pacchetto azionario della società.
La decisione
I giudici di legittimità, partendo dagli elementi fattuali sopra richiamati, affrontano la tematica in esame da entrambi i punti di vista sostenuti dall’azienda: la derogabilità all’uso da parte della contrattazione aziendale e l’incidenza delle vicende di trasferimento societario sulla sussistenza della prassi. Già la Corte d’Appello di Torino si era espressa nel senso dell’impossibilità, per il contratto collettivo, di derogare in pejus retroattivamente in contrasto a diritti già maturati in capo al lavoratore. Il contratto aziendale, infatti, interveniva in un momento successivo rispetto alla maturazione del diritto alla percezione dell’orologio da parte del dipendente: seppur per pochi giorni il diritto risultava già sussistente in capo al lavoratore istante. Ciò appurato, è evidente come il contratto collettivo aziendale non possa, per quanto la Cassazione stessa lo consideri “nel suo complesso migliorativo” rispetto ai trattamenti in essere, derogare a un diritto acquisito con effetti ex tunc.
Riflessione ulteriore già condotta dalla Corte d’Appello, che i giudici di Piazza Cavour richiamano e confermano, apre un tema di tecnica contrattuale di particolare interesse. All’espressione esemplificativa contenuta nell’accordo collettivo, che fa riferimento a “quanto previsto in tema di orologio” viene attribuito ruolo ricognitivo della prassi aziendale di cui i lavoratore lamenta la mancata applicazione. La Corte di Cassazione, infatti, confermando le conclusioni del secondo grado, nega che la sentenza appellata fosse viziata nel suo riconoscere portata ricognitiva all’accordo integrativo: l’esemplificazione contenuta nell’articolo sopra citato è riconosciuta utile al fine di ricostruire la prassi oggetto del procedimento. A prescindere dalle considerazioni legate all’opportunità nel caso specifico di riportare o meno l’esemplificazione citata nel testo dell’accordo, un’indicazione “formativa” che può essere colta dalle conclusioni tratte nell’ordinanza in commento è tecnica: in fase di redazione di un contratto integrativo, è opportuno valutare in modo preciso quanto e come scrivere, senza indulgere alla volontà di massima completezza ed esemplificazione.
Non meno precise sono le indicazioni della Corte di Cassazione in merito all’incidenza della vicenda aziendale sulla prassi di cui si lamenta la mancata applicazione. Anche qui, il giudice di legittimità non ravvisa vizi nell’operato della Corte d’Appello: l’articolo 2112 cod. civ. impone il mantenimento dei diritti maturati dai lavoratori, nel caso in cui operi un trasferimento d’azienda.
È forse questo il punto centrale della vicenda oggetto di analisi: il regime di conservazione del trattamento economico e normativo in occasione di trasferimenti d’azienda dispiega i propri effetti anche nei confronti dell’uso?
A una prima lettura, sembrerebbe ragionevole trarre conclusione affermativa.
Nella misura in cui il trattamento economico frutto di uso è parte del trattamento normativo e retributivo del lavoratore, viene traslato presso il nuovo datore di lavoro a seguito di trasferimento aziendale. Ad avviso di chi scrive, tuttavia, tale assunto non è corretto. Per comprenderne le ragioni, tuttavia, è necessaria una premessa.
Il valore giuridico dell’uso aziendale
L’opinione della giurisprudenza nei confronti del valore da conferire all’uso aziendale ha subito un’evoluzione nel corso degli anni. Rilevando, infatti, la necessità di attribuire il corretto valore alla prassi, i giudici hanno vagliato una prima linea interpretativa, che ad oggi ha ceduto il passo a un punto di vista differente, ora preminente nelle decisioni in materia. Il sotteso operativo, legato a quest’analisi giurisprudenziale, è costituito dalla necessità di vestire correttamente l’uso di modo da comprenderne, innanzitutto, la portata obbligatoria nei confronti del datore di lavoro, ma anche le modalità con cui la prassi deve essere gestita e – nel caso – interrotta.
Il primo orientamento interpretativo poggiava sull’articolo 1340 cod. civ., che recita: “Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti”.
Sulla base di tale automatismo, previsto dalla norma codicistica, si è ritenuto per un rilevante periodo di tempo che nel caso in cui si innestasse una prassi all’interno di un’azienda, la stessa avesse rilevanza individuale nei confronti del lavoratore. In pratica, sulla base dell’articolo 1340 cod. civ., il contratto individuale di lavoro veniva a essere integrato dalla prassi aziendale, attratta nella pattuizione tra datore di lavoro e lavoratore come espressione di una clausola d’uso. La Corte di Cassazione, in questo senso, compiva un ragionamento che, dal punto di vista teorico, ad avviso di chi scrive, era meno criticabile di quanto è stato fatto in seguito. Le maggiori opposizioni in questo senso, in effetti, si concentravano sulla mancata estensione dell’uso ai neo assunti (in quanto diritto cristallizzato nel contratto individuale e suscettibile di non applicazione in futuro se non per i lavoratori che abbiano beneficiato di tale riconoscimento ex articolo 1340 cod. civ.) e su argomenti di tipo equitativo tra le posizioni dei lavoratori inseriti in azienda in momenti differenti. Tali argomentazioni, seppur valide, non avevano elementi sufficienti per scardinare il solido orientamento giurisprudenziale. Ciò che – viceversa – ha spinto verso un’inversione di rotta, come spesso accade, è stata la pratica. Come evidente, infatti, un diritto sorto in virtù d’uso ha necessità di essere gestito in misura collettiva dal datore di lavoro, operando con metodologie che non implichino la novazione contrattuale individuale. Ciò non poteva che essere fatto dando veste collettiva alla prassi, tertium non datur. Per completezza, si segnala una via “ibrida” tenuta dalla Cassazione, che si spinse ad autorizzare la revoca della prassi aziendale con altra prassi successiva, benché meno favorevole, inserita per fatti concludenti. Non si registra un seguito dato alla citata interpretazione, che rimane una pronuncia isolata e di orientamento discutibile.
La linea interpretativa che appare oggi prevalente sceglie, appunto, di dare rilevanza collettiva all’uso aziendale.
La Cassazione, per modificare il proprio precedente orientamento, muove in un certo senso a contrario: se è vero che la prassi aziendale è generalmente applicata alla forza lavoro o a categoria specifica di lavoratori, com’è possibile che l’effetto di tale prassi (che potrebbe sostanziarsi in un singolo episodio che interessi il lavoratore) rinnovi il contratto individuale? Per restare nel caso richiamato, è possibile pensare che il conferimento di un orologio a un dipendente configuri, sulla base di una clausola d’uso, una novazione contrattuale individuale? Partendo da queste domande, il giudice di legittimità ha dato alla prassi aziendale un valore collettivo. In particolar modo, il valore conferito all’uso è parallelo a quello del contratto collettivo aziendale, pertanto suscettibile di modifiche per opera di fonti di pari livello. La Corte si esprime come segue, mostrando il ragionamento alla base dell’inversione di lettura: “Il reiterato comportamento del datore di lavoro fa sorgere l’obbligazione non solo nei confronti dei beneficiari di tale comportamento, ma anche nei confronti degli altri dipendenti, che, in tempi diversi e successivi, conseguiranno la medesima qualifica o si troveranno ad affrontare la stessa vicenda del rapporto. […] non si riesce a spiegare come un’isolata attribuzione patrimoniale, effettuata nei confronti di un lavoratore in una determinata circostanza (nella specie la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione del t.f.r.) possa non solo modificare il contratto di lavoro del dipendente beneficiato (effetto questo fra l’altro del tutto superfluo, una volta che l’erogazione avvenga alla fine del rapporto), ma addirittura integrare il rapporto di lavoro degli altri lavoratori ancora in servizio, facendo sorgere un obbligo dell’imprenditore […] allorché ciascuno di tali lavoratori abbandonerà l’azienda. Per spiegare l’efficacia automatica dell’uso aziendale nei confronti dei singoli contratti individuali di lavoro, sia nell’ipotesi di un comportamento generalizzato che in quella del comportamento ristretto a singole categorie o ad eventi determinati – senza poter ricorrere all’art. 1340 codice civile (applicabile solo in presenza di un uso preesistente al momento della conclusione del contratto) e senza che sia stata convenzionalmente concordata tale modifica – deve necessariamente ritenersi che l’uso aziendale (di carattere negoziale e non normativo) fa sorgere un obbligo unilaterale di carattere collettivo, che agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell’uso aziendale”.
Sempre rimanendo nell’ambito delle fonti collettive, ma con una declinazione differente, si registra una variante dell’orientamento giurisprudenziale qui richiamato. Il giudice di legittimità ha ricostruito la natura dell’uso aziendale fondandosi sulla categoria del fatto-fonte e riconducendo la prassi alla categoria delle fonti sociali collettive nate all’interno dell’ambito aziendale. Ciò pone la prassi al pari di altre fonti di rilevanza collettiva nascenti all’interno del perimetro aziendale, quale ad esempio il regolamento adottato dal datore di lavoro.
Per completezza è bene ricordare che, sebbene quest’ultimo orientamento, nelle 2 declinazioni richiamate, sia prevalente, non è del tutto pacifico. Non è, infatti, unanime l’inquadramento dell’uso come richiamato, sebbene anche la sentenza in commento lo richiami come “più recente”.
La gestione della prassi aziendale
Tutto quanto sopra, come richiamato, ha effetto per quanto riguarda la gestione dell’uso.
Se, infatti, si aderisce alla prima delle interpretazioni date, ossia quella che poggia sulle disposizioni dell’articolo 1340 cod. civ., è necessario un accordo individuale per modificare o rimuovere l’applicazione dell’uso.
Se tale clausola, infatti, fosse inserita nel contratto individuale di lavoro, sarebbe necessario il ricorso alle modalità di modifica dell’accordo individuale per andare a modificare lo stesso contratto. Ciò con tutte le particolarità previste per tale casistica. Importante è sottolineare che, seguendo tale linea di pensiero, la contrattazione collettiva eventualmente intervenuta in seguito non avrebbe la possibilità di modificare quanto attratto nella pattuizione individuale per effetto dell’articolo 1340 cod. civ.. Oltre a ciò, nemmeno nel caso di trasferimento aziendale, in cui operi la sostituzione della normativa collettiva applicata ai dipendenti, il diritto soggettivo sarebbe erodibile da tale modifica.
Nel caso in cui, viceversa, sia data valenza collettiva all’uso, per agire sugli effetti dello stesso sarà possibile operare mediante contrattazione collettiva. In questo senso, sarà data facoltà alle parti sociali che sottoscriveranno l’accordo collettivo di modificare l’uso sia in melius che in peius.
Gli strumenti collettivi, in questo senso, andrebbero ad operare su fonti di pari livello, quindi – appunto – modificabili dagli stessi.
Le vicende societarie e l’uso
In conseguenza di quanto detto, è possibile ricostruire il ragionamento posto in essere dalla Corte di Cassazione nella sentenza da cui il presente contributo prende le mosse. Come anticipato, a una prima lettura potrebbe sembrare che, per effetto dell’articolo 2112 cod. civ., il trattamento retributivo/normativo garantito dall’uso venga traslato in occasione del trasferimento aziendale. Aderendo, tuttavia, alla linea di pensiero sopra richiamata come prevalente, il risultato sarebbe opposto.
È pacifico, infatti, che nel caso di trasferimento aziendale il trattamento collettivo, di pari livello, applicato ai dipendenti del cessionario vada a sostituire quanto applicato presso il cedente.
Per questo motivo, avendo gli effetti dell’uso natura collettiva, un eventuale accordo aziendale avrebbe ben potuto modificarne gli effetti anche in peius.
Ciò che la Corte di Cassazione sottolinea, in questo caso, è individuare correttamente quando si tratti di trasferimento aziendale e quando, viceversa, non ci si trovi in questa casistica. Il giudice di legittimità, in questo caso, sottolinea come il mero trasferimento di quote tra una proprietà e l’altra di un’azienda, quale quella considerata nella pronuncia, non integri la fattispecie del trasferimento aziendale.
Esiste, infatti, una solida linea giurisprudenziale che esclude il trasferimento del pacchetto azionario dalle casistiche di trasferimento. Il trasferimento delle quote, infatti, non incide sui rapporti esistenti tra la società oggetto di cessione e i terzi, pertanto non si ritiene che il rapporto di lavoro sia interessato dalla casistica della cessione del pacchetto azionario afferente a una società. Da qui la conclusione tratta dalla sentenza in commento: non è il trasferimento a non aver interessato il diritto derivante da uso, il permanere di tale diritto deriva dal fatto per cui non vi è stato alcun trasferimento societario ai fini della gestione dei rapporti di lavoro.
Riconoscere la prassi aziendale
Tematica rilevante, in relazione alla prassi aziendale, riguarda la modalità di ricognizione dell’uso stesso.
Quando, infatti, è possibile riconoscere la presenza di un uso? Cosa può essere considerato uso?
La risposta scolastica alle domande ora richiamate individua la prassi aziendale, o uso aziendale, in un comportamento migliorativo rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, sia di carattere economico che di carattere normativo, erogato alla generalità dei lavoratori, ovvero a categorie omogenee di essi, non in virtù di contrattazione individuale o collettiva, bensì per effetto di un comportamento tenuto in modo ciclico e continuo da parte del datore di lavoro. Tanto ciclico e continuo da assurgere al rango di diritto sorto da prassi.
Il comportamento, per essere considerato uso, deve essere tenuto spontaneamente dal datore di lavoro (con l’esclusione, pertanto, delle condotte tenute per effetto di errore), ma non è necessario che il datore di lavoro abbia la ferma volontà di riconoscere un plus rispetto alla disciplina generalmente applicabile: il fatto che il comportamento sia liberale e non vincolato, fonda esso stesso la possibilità di riconoscervi una prassi aziendale. La Cassazione, in questo senso, ha chiarito che non è necessario che il comportamento sia volontariamente atto a migliorare il trattamento applicabile.
Altro carattere fondamentale nell’individuazione dell’uso è un’apprezzabile reiterazione del comportamento, sulla base di periodi significativi, con applicazione dello stesso alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee degli stessi.
In questo senso, può essere considerata prassi l’erogazione continuativa di un elemento retributivo, purché interessi una categoria precisa di lavoratori dell’impresa. Anche un’eventuale gestione delle ferie, dei permessi o dell’orario di lavoro può costituire uso aziendale. Perché ciò sia configurabile è necessaria, anche in questo caso, la reiterazione nel tempo e l’individuazione di una categoria omogenea di lavoratori a cui la condotta sia stata applicata. Esempio classico, di cui è semplice rinvenire casistiche trattate dalla giurisprudenza, è il caso della gestione dell’orario giornaliero (ad esempio la possibilità data ai dipendenti di lasciare la postazione lavorativa in anticipo, la possibilità di gestire le pause nella giornata in un certo modo …): nel caso in cui il datore di lavoro acconsenta, o anche incoraggi, una data gestione, la stessa potrebbe essere ricondotta nella categoria delle prassi aziendali, con le conseguenze sopra richiamate.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Strumenti di lavoro“.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: