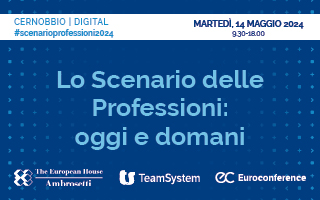Di vaccini, licenziamenti e ragionevoli dubbi
di Evangelista Basile
La pandemia causata dalla diffusione del COVID-19 ha portato con sé numerose nuove questioni, che sono ben presto divenute oggetto di dibattito tanto nella società civile quanto nelle aule di Tribunale.
Dal punto di vista del diritto del lavoro, al netto delle problematiche interpretative sorte a seguito dell’emanazione della legislazione di emergenza, uno dei temi più scottanti è stato, fin dagli albori della pandemia, quello della responsabilità del datore di lavoro in relazione al proprio obbligo di protezione della salute dei dipendenti.
Come noto, tale obbligazione trova il proprio fondamento nell’articolo 2087, cod. civ., secondo cui “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Tale norma, a sua volta, è – da una parte – necessario corollario di diritti di rango costituzionale, quale quello alla salute (articolo 32, Costituzione) e quello di libertà di iniziativa economica (articolo 41, Costituzione) e, dall’altra, norma di chiusura del sistema di tutele dell’integrità del lavoratore, configurandosi dunque come norma di carattere generale a finalità prevenzionistica.
Occorre fin da subito rilevare che proprio i caratteri appena detti di questa norma hanno, negli anni, condotto la giurisprudenza ad ampliare enormemente (e talvolta anche in maniera opinabile) la portata dell’obbligo in capo al datore di lavoro di “prevenire” tutto ciò che possa ledere la salute dei prestatori di lavoro.
Pertanto, secondo l’interpretazione ormai consolidata, l’imprenditore, nell’esercizio del suo potere organizzativo, è tenuto a valutare e prevenire anche rischi provenienti da agenti provenienti dall’esterno dell’azienda, come per esempio gli agenti atmosferici cui i dipendenti possono essere esposti nello svolgimento della prestazione, i comportamenti imprudenti o addirittura dolosi di terzi o gli agenti patogeni di cui possa essere portatore un utente del servizio o un fornitore. Ci si figuri come si possa ritenere del tutto libero l’imprenditore dal prendere iniziative atte a contrastare la diffusione di un virus, il cui contagio – per stessa ammissione del Legislatore (articolo 42, comma 2, D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020) – è da ritenersi infortunio sul lavoro.
All’inizio del 2020 il problema era, infatti, sostanzialmente legato all’eventuale contagio avvenuto sul luogo di lavoro (l’Inail, per alcune categorie, al fine di riconoscere l’indennità di infortunio, lo ha addirittura presunto).
A un anno dalla pandemia, la discussione si è, invece, spostata (sebbene la precedente non abbia ancora definizione!) sulla vaccinazione quale strumento di prevenzione da adottare da parte del datore di lavoro proprio al fine di ottemperare a quell’obbligo di cui all’articolo 2087, cod. civ., e sul parallelo diritto del prestatore di lavoro di (non) sottoporsi a un simile trattamento sanitario.
La questione, lungi dal voler essere solo uno scontro tra le ragioni del sì o del no al vaccino, è di importanza fondamentale: da una parte, infatti, il datore di lavoro che non “imponga” (contrattualmente) ai propri dipendenti il vaccino rischia poi di essere ritenuto responsabile di un eventuale contagio in azienda e, dall’altra, la medesima imposizione può essere, invece, considerata illegittima, perché in violazione dei diritti costituzionali della persona.
La dottrina si è, dunque, divisa fra chi ha sostenuto che il datore di lavoro possa (e, anzi, in virtù dell’articolo 2087, cod. civ., debba) imporre la vaccinazione, pena il licenziamento (o quanto meno la sospensione del rapporto di lavoro) e chi, invece, ha ritenuto che il datore di lavoro non possa obbligare i prestatori di lavoro a disporre di un proprio diritto fondamentale sotto il “ricatto” del recesso.
Come spesso accade, in medio stat virtus e non tanto nel senso di voler abbracciare una tesi piuttosto che un’altra, ma nel senso – per rimanere in tema di prevenzione – di voler essere prudenti nella gestione di una problematica ancora tutta in divenire.
In linea di principio, infatti, l’obbligo di prevenzione del datore di lavoro è talmente vasto da non far ritenere possibile un’esclusione di responsabilità per questa specifica questione, il che farebbe assolutamente propendere per una prudente imposizione della vaccinazione ai propri dipendenti.
Fra l’altro, è appena il caso di accennare al fatto che l’emergenza sanitaria ha toccato e compresso anche altri diritti e libertà costituzionalmente garantiti, fra i quali quello alla “non vaccinazione” non assurge di certo al più importante.
Ovviamente sarebbe – come al solito – auspicabile un intervento normativo che introduca l’obbligo di vaccinazione (come già previsto per altre patologie), che taglierebbe così la testa al toro e renderebbe chiari i rapporti di forza fra il 2087, cod. civ., e la riserva di legge di cui all’articolo 32, Costituzione.
In assenza, però, la questione non può essere tenuta in sospeso: si pensi a tutte quelle categorie di lavoratori (operatori sanitari, in primis) già interessati dalla c.d. Fase 1 del piano di vaccinazione.
Cosa succede in caso di rifiuto? Può il datore di lavoro licenziare il lavoratore che non si voglia vaccinare?
Il problema non è affatto di facile risoluzione. A sostegno della tesi dell’obbligo, in effetti, oltre all’articolo 2087, cod. civ., vi è un’altra norma particolarmente interessante, che ci permette di guardare anche e specularmente agli obblighi del prestatore di lavoro quale cittadino e quale necessario collaboratore dell’imprenditore nella messa in atto degli obblighi di salute e sicurezza incombenti su quest’ultimo.
Si tratta di una norma contenuta nel T.U. salute e sicurezza sul lavoro, all’articolo 20, che recita: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni e omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
Il tema, pertanto, a parere di chi scrive, andrebbe spostato sulla definizione della funzione del vaccino per il COVID-19 nello specifico, ovvero se quest’ultimo abbia funzione di protezione solo personale, e quindi del solo vaccinato, o se, invece, le caratteristiche del vaccino siano tali da riuscire a proteggere anche gli altri. Ad oggi la risposta sugli effetti della vaccinazione non è univoca, ma è di tutta evidenza che, ove fosse la seconda ipotesi quella corretta, scatterebbe inevitabilmente quell’obbligo di cooperazione del lavoratore di cui all’articolo 20, T.U..
In ogni caso – e in considerazione di tutti i dubbi finora espressi, che varieranno anche sulla base dell’andamento della pandemia stessa – la soluzione dovrebbe essere ricondotta ai principi generali di buona fede e correttezza, che vedono il recesso dal rapporto quale extrema ratio, ben potendosi, in caso di rifiuto alla vaccinazione (che, ricordiamolo, potrebbe anche essere giustificato e non semplice presa di posizione negazionista!), invece, preferire più ragionevoli e più conservative ipotesi, quali l’adibizione a mansioni a minor rischio di contagio, la sospensione del rapporto (e del correlato obbligo retributivo) o – dove possibile – l’esercizio della prestazione in modalità a distanza (così come si è fatto durante la pandemia).
Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: