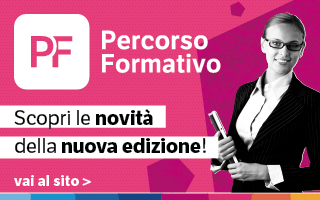Il licenziamento ai tempi di Facebook: rilevanza disciplinare dell’uso dei social network
di Andrea Asnaghi
Con sempre maggior frequenza, la rete, e in particolare i c.d. social network, influenzano la vita delle persone e sono diventati strumento di relazione, di comunicazione e di espressione. Ciò ha portato indubbi riflessi sotto il profilo sociale e personale e su questo aspetto uno dei rilievi più importanti è l’abuso o la fruizione non accorta di tali strumenti, di cui purtroppo si sottovaluta – anche per la loro facilità di accesso e di fruibilità – la portata “pubblica” e la larga diffusione (quantomeno potenziale), con conseguenze a volte compromettenti per la vita reale. Anche il rapporto di lavoro non sfugge alla regola generale e spesso il lavoratore rischia di incappare – anche preterintenzionalmente – nella violazione di norme di correttezza, fedeltà e buona fede, con ripercussioni piuttosto gravi, e finanche radicali, dal punto di vista disciplinare e non solo. Il presente contributo ripercorre tali temi partendo dalla sentenza di Cassazione n. 10280/2018.
I social e il rapporto di lavoro
È innegabile l’influenza via via crescente che l’uso dei canali “social” sta avendo sulla vita delle persone, non solo per le nuove generazioni, ma anche per coloro che, formatisi nell’era analogica, riscoprono nella vita adulta le potenzialità del digitale e del virtuale. La normalità, direi anzi la familiarità, con cui queste forme di comunicazione e di socializzazione entrano nel quotidiano, spesso fanno tuttavia il paio con un loro uso scriteriato o inopportuno o, quantomeno, privo di buon senso e razionalità.
Alcuni fattori ricorrenti nelle dinamiche di utilizzo e approccio dei social concorrono a tale cortocircuito mentale:
- la ricerca dell’approvazione sociale (virtuale) a qualunque costo, del piacere e riscuotere consensi, con relativa perdita del senso critico e della dimensione reale dell’esistenza,
- altrettanti effetti sono dati dall’assoluta eterogeneità dei contenuti e delle opinioni: si può credere di poter dire di tutto e discettare di tutto, rapportarsi con tutti, annullare distanze (sociali e culturali) che invece realmente esistono e ingannarsi sulle reali capacità personali di comprensione e di dibattito;
- la forma di immediatezza e velocità delle risposte e delle azioni, che da un lato determinano un uso dell’intelletto inversamente proporzionale alla rapidità delle stesse e, dall’altro, richiedono talvolta un bisogno di superconnessione quasi in tempo reale (d’altronde, se si arriva a confondere quella con la vita vera, il tempo in cui si è disconnessi è parificato a un non-vivere).
Anche, quindi, senza arrivare a dimensioni patologiche – che pure esistono e vengono costantemente studiate – appare chiaro che un cattivo uso dei social network può comportare effetti devastanti sulla vita personale e di relazione. A questo problema non sfugge certo anche il rapporto di lavoro. Sempre più spesso, infatti, emergono contenziosi scaturiti dall’abuso o uso improprio della rete.
Per motivi di spazio, non ci vogliamo soffermare qui, se non per un doveroso cenno, su uno degli aspetti ricorrenti della questione “social” ovvero l’accesso frequente o ripetuto ai siti estranei alla prestazione in costanza di rapporto di lavoro (cioè durante l’orario di lavoro, che dovrebbe essere dedicato alle pertinenti mansioni), tale da determinare una depressione della produttività e, in qualche caso, l’acquisizione di poco simpatici virus informatici (o altri programmi spia o comunque di appesantimento e intralcio all’operatività aziendale). Quando tali accessi siano effettuati con mezzi aziendali si apre il problema – non ancora risolto, malgrado la recente revisione dell’articolo 4, L. 300/1970 – delle possibilità di controllo e di acquisizione di tali dati da parte del datore di lavoro mediante l’utilizzo dei software di tracciatura ormai generalmente installati su ogni sistema informatico. Il tutto è complicato dalla non sempre armonica disciplina in materia di privacy, di cui le autorità garanti in un’ottica liberale (assurdamente garantista a parere di chi scrive) sono arrivate a formulare un diritto non meglio specificato del lavoratore a continuare sviluppare (fortunatamente, è stato almeno specificato “in modo contenuto”) una normale vita di relazione (virtuale) anche sul posto di lavoro.
Si aprono vari problemi, sotto questo profilo: da cosa considerare (rispetto alla nuova formulazione dell’articolo 4, St. Lav.) “strumento in uso” al lavoratore, alla necessità di un disciplinamento attraverso policy o regolamenti specifici che determinino con esattezza le disposizioni aziendali sul tema, informando anche analiticamente e con puntualità sulle eventuali forme di controllo o verifica in cui potrebbero incorrere le azioni del lavoratori.
Tuttavia ciò di cui vorremmo occuparci compiutamente è la relazione fra le pubblicazioni che un lavoratore può mettere in rete e la loro eventuale rilevanza sotto il profilo disciplinare, partendo dai rilievi di un’interessante sentenza.
I contenuti espressi da un lavoratore nei social network: come possono influire sul rapporto? Le tesi di Cassazione n. 10280/2018
La sentenza della Cassazione n. 10280/2018 si è occupata (confermandone la legittimità, come già avevano fatto le Corti di merito) del licenziamento di una lavoratrice che, sulla propria bacheca virtuale di Facebook, aveva espresso frasi di disprezzo nei confronti dell’azienda per cui lavorava e del suo legale rappresentante (letteralmente: “mi sono rotta i coglioni di questo posto di merda e per la proprietà”); la fattispecie era stata oggetto di rituale contestazione ex articolo 7, L. 300/1970, con procedimento esitato nel licenziamento per giusta causa. È anzitutto evidente per il giudicante che, pur non essendoci esplicita nomina né dell’azienda per cui operava la lavoratrice, né dell’amministratore a cui si riferiva, entrambi fossero facilmente identificabili dai destinatari e che, quindi, si fosse realizzata una sostanziale diffamazione.
Inoltre, nel contestare i motivi di ricorso della lavoratrice, la sentenza offre alcuni importanti spunti di riflessione.
La lavoratrice aveva infatti sostenuto (lamentandone la mancata valorizzazione da parte dei giudici di merito) l’assenza di qualsiasi intenzionalità nella condotta tenuta, dovuta (oltre che a situazioni di stress personale) alla non consapevolezza e all’involontarietà di pubblicità del messaggio, nelle intenzioni rivolto alla propria limitata sfera di interlocutori.
La lavoratrice aveva inoltre sostenuto che non era stata valutata la proporzionalità fra violazione e sanzione, riducendo le espressioni usate a un mero “sfogo” personale, privo di un reale disprezzo nei confronti dell’azienda, e con l’uso di modalità espressive usuali nel linguaggio comune e volte a manifestare semplicemente un proprio personale disagio, senza altri intenti.
Nel respingere le tesi della ricorrente, la Cassazione premette un importante principio: pur dovendosi tenere in conto (per poter parlare di giusta causa) del comportamento in concreto del lavoratore anche sotto il profilo soggettivo – cosicché per valutare la lesione del vincolo fiduciario si devono prendere in considerazione anche aspetti complessivi (mansioni del lavoratore e grado di responsabilità in azienda, motivi e circostanze del suo agire, volontarietà ed intensità dell’intenzione) – non è però necessario che la condotta del lavoratore debba necessariamente presentarsi come intenzionale o dolosa, e quindi anche un comportamento colposo può essere idoneo a portare al licenziamento.
Volendo parafrasare il concetto, ai fini della legittimità di un licenziamento – ci dice la Cassazione nella sentenza in commento – non è necessario essere “cattivi” o maliziosi, basta essere sufficientemente “stupidi” o faciloni.
Il che non porta sicuramente a conclusioni automatiche o scontate, dato che non si può ritenere che l’accertamento del giudice finisca per accogliere automaticamente le tesi datoriali, ma ciò dovrebbe fungere da monito sufficiente – in tutti i casi in cui il dipendente ritenga che basti a posteriori giustificarsi con un “non volevo” – a consigliare una condotta prudente e orientata al buon senso anche nelle pubblicazioni sui social.
La medesima prudenza va peraltro suggerita pure alla reazione del datore di lavoro: la giurisprudenza di merito e di legittimità, invero, spesso orientata a considerare il licenziamento quale ultimissima spiaggia (ovvero attivabile unicamente in casi che rasentano l’eccezionalità), non di rado sarà in grado di trovare eccezioni o cavilli per dedurre l’illegittimità di un licenziamento in una simile situazione, magari cavalcando la tesi della sproporzione o quella della scarsa rilevanza della posizione del lavoratore nel contesto aziendale. E in tal senso, in sede di legittimità, a meno di evidenti vizi formali o logici, eventuali diverse argomentazioni non potranno essere prese in considerazione, in quanto rimesse all’insindacabile, se adeguatamente motivata, valutazione del giudice di merito (il che è quanto avvenuto anche nella sentenza in commento, seppure con destino contrario, cioè con la conferma dell’accertamento della legittima del licenziamento impugnato nella sentenza de qua).
Il secondo aspetto interessante della sentenza n. 10280/2018 è la riconferma che l’uso della rete e dei social media abbia la “potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato (…) ai fini di una costante socializzazione”, mezzo pertanto idoneo “a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica”, integrando pertanto – qualora siano identificabili, anche per relationem, i soggetti destinatari del commento – a integrare il reato di diffamazione.
La sentenza, quindi, considera per acquisita la riflessione già posta in essere in maniera sostanzialmente univoca dalla giurisprudenza penale, che ritiene che le offese in rete integrino non solo il reato di diffamazione ex articolo 595 c.p. (più grave di quello di ingiuria, articolo 594 c.p., in quanto attuato “comunicando con più persone”), ma anche l’aggravante di cui al comma 3 del medesimo articolo (offesa “a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”): in tal senso la rete è in maniera costitutiva un veicolo di diffusione potenzialmente illimitato per sua stessa natura, in quanto volto ad amplificare la comunicazione e l’interscambio sociale ben al di là degli eventuali soggetti eventualmente ammessi nella cerchia di amici e conoscenti autorizzati ad accedere ai contenuti di un determinato utente.
Ciò, a parere di chi scrive, consente di evitare di perdersi in considerazioni – che appaiono senza fine, soprattutto nella rinnovata disposizione GDPR – sulla liceità e legittimità dell’utilizzo delle espressioni, commenti e immagini utilizzati dal lavoratore sui social media senza una preventiva informativa (o addirittura ottenimento del preventivo consenso) da parte del datore di lavoro ai sensi della normativa privacy.
Fermo restando, infatti, quanto stabilito all’articolo 8, St. Lav. (divieto di indagine sulle opinioni dei lavoratori o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale) e di ogni altra attività valutativa a carattere potenzialmente discriminatorio o invasivo della sfera personale, qui si tratta semplicemente di essere riceventi – in modo anche sostanzialmente passivo – di contenuti che l’autore si è premurato di diffondere, ovverossia di favorirne urbi et orbi la conoscibilità.
Al riguardo, poi, alcuni autori si sono chiesti se la diffamazione a mezzo internet o stampa rientri nei comportamenti espressamente vietati dall’articolo 2015 cod. civ. (obbligo di fedeltà) o latamente dal 2104 (diligenza), costituendone una violazione specifica, oppure se essi non vadano a ledere una sorta di “obbligo sociale atipico” (cioè non codificato esplicitamente), ma consistente nel diritto del datore di lavoro a non vedere incisa la sfera giuridica della propria rispettabilità, che integra la traslazione della stessa anche sul buon nome della propria impresa e della sua proiezione economica e organizzativa sul mercato.
Tale distinzione avrebbe senso in quanto, nella seconda ipotesi (azzardata ma non priva di ragionevolezza), la fattispecie oggetto di considerazione (diffamazione sui social) travalicherebbe i limiti della violazione dei normali obblighi del rapporto di lavoro, innestandosi nel mancato rispetto dei più generali doveri sociali, riconoscibili e attivabili senza bisogno di alcuna informazione o regolamentazione specifica (o di previsione contrattuale) e che metterebbero in secondo piano anche l’eventuale valutazione di gravità parametrata ad altri aspetti del rapporto di lavoro (reiterazione, recidiva, posizione del dipendente nell’organizzazione aziendale, etc.).
I comportamenti “social” dei lavoratori da evitare e le cautele del datore di lavoro
Analizzati gli spunti più salienti della sentenza in commento, come riflessione conclusiva che prende spunto dalle sollecitazioni della stessa, vorremmo chiudere con una sintetica carrellata di quelle che sono le fattispecie ricorrenti o che si sono presentate in questi anni – non solo a livello giurisprudenziale, ma nell’esperienza concreta di chi scrive e di propri colleghi – rispetto al tema trattato; in particolare concentrandosi sugli aspetti più “ingenui” (e quindi ove un’imprudente leggerezza si rivela particolarmente traditrice), con esclusione degli aspetti marcatamente dolosi.
Anzitutto, pare utile dividere i comportamenti a rischio in 3 grosse macro-categorie:
- comportamenti (latamente) offensivi o ingiuriosi, denigratori o comunque fonte di disprezzo o dileggio o palese ostilità verso un soggetto;
- comportamenti che violano il dovere di riservatezza o segretezza o di fedeltà e affidabilità in genere;
- comportamenti personali del tutto estranei all’ambito lavorativo, ma che sono idonei a determinare una perdita del vincolo fiduciario in relazione agli aspetti legati al rapporto di lavoro.
All’interno di ciascuna di queste categorie, bisogna poi osservare che il contenuto illecito o a rischio:
- può essere dato non solo da uno scritto, ma da un’immagine, un video, una canzone, un accostamento fra testo e immagini o musica, una citazione, il rilancio di uno screenshot, insomma il rischio si connette a tutta la “potenza comunicativa” (sempre in evoluzione) che i social mettono a disposizione;
- non deve necessariamente essere riferito al datore di lavoro o al legale rappresentante o alla proprietà in genere, ma può anche riguardare una sfera di soggetti comunque inerenti al rapporto di lavoro (ad esempio colleghi, sottoposti, superiori, clienti, fornitori, etc.), dei quali l’offesa o la violazione di riservatezza possono dare luogo a valutazione addirittura peggiore che se fossero rivolte verso il datore di lavoro.
Sul primo gruppo abbiamo già espresso alcune considerazioni nel paragrafo precedente; qui occorre rilevare la differenza fra un’offesa e un generale diritto di critica (per giurisprudenza costante, sempre possibile, purché non sfoci in apprezzamenti denigratori o gratuitamente lesivi della dignità delle persone o in fatti volti a danneggiare volontariamente l’azienda), così come rimarcare che la pretesa tenuità del comportamento – sminuito a posteriori a livello di “sfogo” personale o mera reazione impulsiva ad una provocazione – mal si combina con i meccanismi di realizzazione dei post (la scrittura, in quanto tale, e ancor di più la pubblicazione di immagini, richiedono comunque, anche in chi tecnologicamente è più scafato, un’attività di elaborazione, concettualizzazione e attuazione operativa che depongono a favore di un’intenzionalità più o meno accentuata). Inoltre, pur senza arrivare agli estremi del cyberbullismo, anche comportamenti denigratori verso semplici colleghi potrebbero innescare una reazione datoriale, soprattutto qualora gli stessi si innestassero in un insieme, conglobato anche con aspetti della vita lavorativa, di comportamenti vessatori o di mobbing orizzontale, ma talvolta anche solo per la loro idoneità a deprimere il clima aziendale.
A volte, a cavallo fra il gruppo a e il gruppo b si situano apprezzamenti negativi verso terzi (clienti, fornitori, etc.) o la loro organizzazione: ciò può avere rilievo, infatti, magari non per un aspetto denigratorio o offensivo, ma anche soltanto per la potenziale violazione della riservatezza dovuta al terzo.
Ad esempio, rischierebbe il licenziamento o un serio provvedimento disciplinare l’addetto a manutenzioni o pulizie che fotografasse e pubblicasse una situazione particolarmente spregevole (per sporcizia, degrado, cattivo stato, disorganizzazione, etc.) di un cliente.
Particolarmente rischiose poi, proprio perché dettate spesso da leggerezza e assenza di intenzioni malevole (e quindi, scioccamente ritenute innocenti – ma nei fatti causa di effetti nocivi) sono le violazioni di aspetti riservati, quasi alla stregua di segreti industriali: si può trattare, ad esempio, della pubblicazione della foto di un prototipo ben riuscito oppure di un modello che sta per essere commercializzato sul mercato o, ancora, di osservazioni e commenti che rivelino un certo modello organizzativo aziendale riservato. Se non fatti a scopo di lucro o con altri scopi intenzionalmente dolosi (ad esempio, a titolo di concorrenza), spesso ci si trova di fronte a tali comportamenti incautamente dannosi, la cui inopportunità, una volta messi di fronte alle conseguenze (ma è già tardi), sono gli stessi lavoratori a riconoscere.
Anche il gruppo c può dare luogo a diversi inconvenienti, ma qui il terreno è obiettivamente più scivoloso, andando a impattare su scelte del lavoratore di tipo personale e per le quali non può certo essere discriminato. Tuttavia, la particolare violenza o crudezza o inaccettabilità sociale di determinati contenuti divenuti “pubblici”, anche in relazione alle mansioni svolte, può generare apprezzamenti dal punto di vista disciplinare.
Particolarmente curiosi – e rischiosi–sono gli aspetti in cui la manifestazione di opinione coinvolge il datore di lavoro in maniera impropria.
Esempio (fatto realmente accaduto ma di cui, ovviamente, si riporta solo il senso, alterando possibili individuazione di soggetti): un gruppo di dipendenti dell’azienda X manifesta sui social l’adesione a una determinata iniziativa di carattere politico, con tanto di foto di un gruppo di dipendenti (in reparto aziendale, ampiamente riconoscibile) e striscione e con la dicitura che “anche l’azienda X è contro …”, con l’approvazione del responsabile del reparto in oggetto, che ha partecipato alla foto; il tutto nella convinzione di assumere un’iniziativa condivisibile in via generale, ma dal chiaro sapore di parte e esponendo il nome dell’azienda senza autorizzazione del datore di lavoro, con evidente grave violazione (in “buona fede”!) dell’elemento fiduciario.
Pare utile ancora una volta ricordare, proprio sulla scorta della sentenza commentata in precedenza, che non potrà costituire valido scudo verso eventuali contestazioni la pretesa “riservatezza” dei profili social, atteso che qualsiasi sia il grado di privatizzazione o di limitazione all’accesso degli stessi, essendo gli stessi ambiti che si caratterizzano “ontologicamente” per finalità di massima pubblicità e diffusione.
Qualche consiglio, infine, può essere rivolto anche ai datori di lavoro.
- Non si dia per scontato, anzi si valuti con la massima accortezza, la negatività del comportamento del lavoratore; se ci sono stati dei danni (di immagine o commerciali, anche potenziali) meglio evidenziarli già in fase di contestazione; e la stessa cosa deve avvenire per eventuali altri comportamenti o precedenti che eventualmente possono rendere il quadro complessivo dell’intenzionalità e ricorrenza di un determinato atteggiamento; viceversa, l’occasionale stupidata o uscita estemporanea del lavoratore potrà supportare sì un provvedimento disciplinare, ma non necessariamente un licenziamento. L’esito (nel caso di specie, confermativo del licenziamento) dell’iter giuridico relativo alla sentenza commentata in precedenza non può dare certezze, ma solo fornire alcuni utili spunti (come abbiamo cercato di evidenziare).
- Se possono essere messi in atto dai lavoratori comportamenti (ad esempio in termini di riservatezza) ritenuti a rischio, si predisponga un minimo di regolamento, si prevedano direttive e momenti di formazione (e a volte anche istruzioni sul caso specifico) atte a prevenire eventuali inconvenienti che, soprattutto se forieri di danni verso terzi, vedrebbero anzitutto l’esposizione di responsabilità del datore di lavoro.
- La valutazione di eventuali affermazioni, comportamenti o comunicazioni del lavoratore sia sempre effettuata in ordine ai principi di fedeltà, affidabilità e diligenza, soppesando in particolare la reale valenza e pregnanza in concreto, e non in astratto, delle ricadute di tali comportamenti. E anche nei confronti dei soggetti eventualmente più invisi (o meno collaborativi), si evitino rischiosi processi alle intenzioni o alle opinioni, sulle quali sussiste la massima libertà di espressione, finanche in senso contrario alle eventuali politiche o scelte organizzative aziendali.
- Infine, si tenga presente che un conto è venire a conoscenza di un’espressione del lavoratore, un altro conto è il sistematico e continuo monitoraggio delle attività del lavoratore sui social, che potrebbe configurare un ipotesi di trattamento di dati soggetta ad adeguata informativa e consenso, ma, prima ancora, bisognosa di un’attenta valutazione preliminare in termini di legittimità, liceità e pertinenza.
In una parola finale: per tutti, come sempre, tanta prudenza e buon senso, per evitare di guastare un rapporto, quello di lavoro, che deve basarsi sull’armonia e la condivisione, se non anche di intenti, quantomeno di codici comportamentali e operativi ispirati a una reciproca e intelligente buona fede.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: