Effetti sulla gestione del personale del Decreto Dignità
di Cristian Valsiglio
Il Decreto Dignità, D.L. 87/2018, così come convertito dalla L. 96/2018, pone aspetti di gestione del personale molto delicati e complicati, che richiedono riflessioni più approfondite rispetto alle attuali analisi interpretative di diritto.
Tali riflessioni, seppur solo abbozzate, non devono tuttavia perdere di vista il quadro d’insieme delle disposizioni in essere e in divenire.
Il frutto delle scelte gestionali, che spesso hanno “stressato” l’utilizzo degli strumenti forniti dal Legislatore in questi ultimi anni, hanno dato adito ad alcuni ripensamenti ben rappresentati dalla ratio delle disposizioni presenti nel Decreto Dignità, volti da un lato a incrementare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e dall’altro a scoraggiare licenziamenti scellerati.
Pur partendo da buoni e nobili intenti, la disposizione si è sviluppata in 2 direzioni sui temi lavoristici: la creazione di forti limiti all’utilizzo del contratto a termine e l’aumento degli indennizzi risarcitori dei licenziamenti sotto tutele crescenti.
In merito all’utilizzo dei contratti a termine è chiaro che l’obiettivo è stato quello di evitare situazioni in cui il lavoratore richiamato con diversi contratti di lavoro proseguisse nella medesima mansione per 36 mesi senza avere alcuna certezza nel futuro e così limitando le sue progettualità personali (fare famiglia, comprare casa, etc.).
Ma perché i datori di lavoro utilizzano i contratti a tempo determinato?
Da una parte vi è sicuramente l’intento di provare in modo efficace il lavoratore nella mansione; dall’altra le difficoltà economiche, effetto di una crisi finanziaria senza eguali, hanno indotto gli imprenditori a fare scelte caute in attesa del consolidamento della ripresa.
La prima delle 2 motivazioni è quella che induce maggiori riflessioni nel campo del diritto, in quanto lo strumento per provare il lavoratore è già esistente ed è il periodo di prova. Tuttavia, i datori di lavoro hanno spesso la necessità di verificare le attitudini del lavoratore sul lungo periodo e non sul breve e, pertanto, utilizzano il contratto a termine per paura che una stabilizzazione a tempo indeterminato poi prosegua nella necessità infausta di licenziare con difficoltà lo stesso lavoratore.
Per evitare questa seconda paura il Decreto Dignità non fa nulla; in quanto, aumentando le misure delle indennità da concedere al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, non ha fatto altro che aumentare il costo del contenzioso. Ma sul tema si è anche in attesa di una decisione della Corte Costituzionale.
In tema di politica gestionale del personale si rileva, quindi, un doppio aumento del costo del contenzioso: il primo collegato alla fragilità delle causali da indicare e il secondo collegato all’aumento delle misure minime e massime dei risarcimenti del licenziamento illegittimo; seppure quest’ultimo aumento potrebbe essere calmierato dall’utilizzo della conciliazione esente prevista dall’articolo 6, D.Lgs. 23/2015, anch’essa con limiti minimi e massimi incrementati.
La netta fragilità delle causali che si possono sostanzialmente apporre per esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, ovvero per esigenze temporanee, significative e non programmabili dell’attività ordinaria (salvo il caso della sostituzione del lavoratore), consente di identificare la ratio della disposizione nel motto: provo il lavoratore per 12 mesi liberamente, se va bene lo devo trasformare a tempo indeterminato se, invece, non mi convince, poiché le proroghe e i rinnovi devono essere effettuati in presenza di una causa a forte rischio contenzioso, farò terminare il contratto e assumerò un nuovo lavoratore con contratto a termine nella medesima mansione.
Quale l’effetto?
Un forte aumento di un turn over “cattivo” (come il colesterolo) in cui nessuno è vincitore: il lavoratore perde il posto di lavoro, mentre il datore di lavoro deve iniziare nuovamente il percorso con un altro lavoratore, con chiari effetti sulla produttività e sui costi aziendali.
In realtà, potrebbe ritenersi vincitore il futuro lavoratore a termine, ma la vincita durerebbe 12 mesi, per poi essere sconfitto in caso di dubbi dell’impresa.
Un punto di sintesi, forse troppo velocemente accantonato, sarebbe stato quello di consentire la libera apposizione del termine fino a 24 mesi (e non 12 mesi), tempo probabilmente più congruo nel rispetto degli intenti delle parti: dell’impresa nel decidere di confermare il lavoratore e/o le strategie di business; del lavoratore di mantenere un rapporto di lavoro, ancorché a termine, fino a 24 mesi, per poi capire di dover cambiare azienda senza attendere 36 mesi di continui strappi e rilanci.
Uno spunto di riflessione per una eventuale riforma del contratto a termine: l’ennesima.
Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:




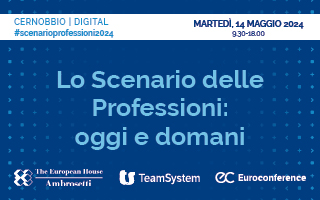




18 Settembre 2018 a 10:14
Riflessione pienamente condivisibile.
18 Settembre 2018 a 11:31
Assolutamente condivisibile. A proposito di “colesterolo cattivo” o dinamiche contorte del Decreto, alcune agenzie di somministrazione stanno contattando dei clienti millantando la possibilità di “azzerare” i contatori del numero dei mesi a tempo determinato svolti presso di loro dai dipendenti a termine, sostenendo che se venissero assunti da loro e somministrati alle Aziende, dal 14/7 per effetto dell’entrata in vigore della norma, tale contatore, a favore delle Agenzie si azzera? Secondo Lei è corretta questa impostazione?