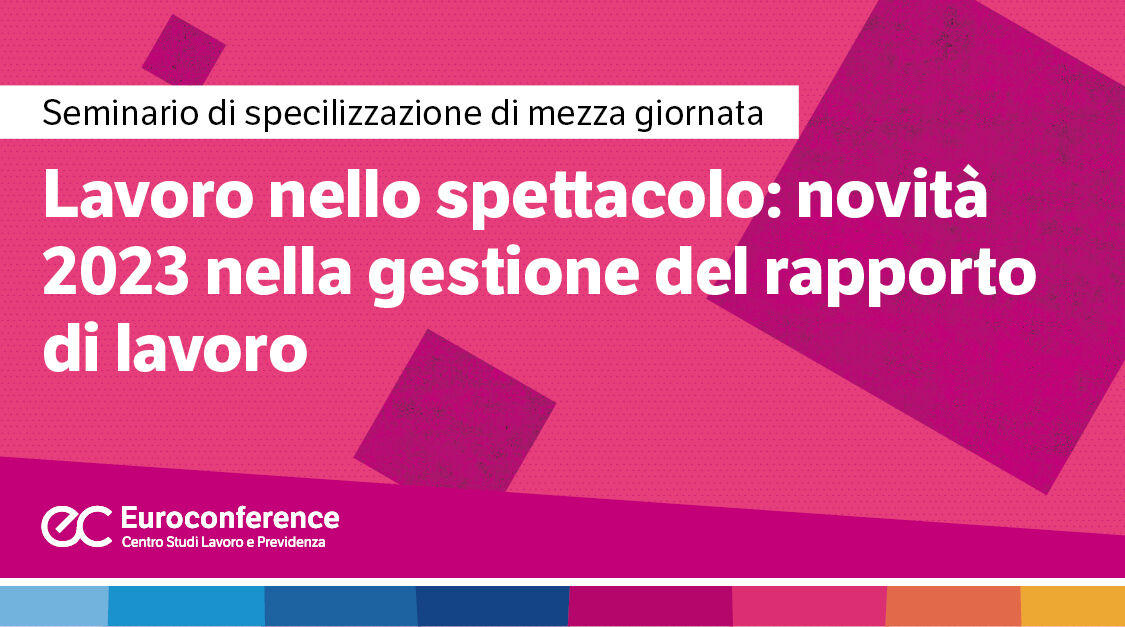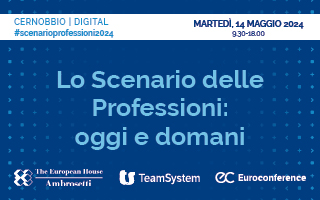Lavoro intermittente, assenza del DVR e riqualificazione del rapporto
di Alberto Borella
L’articolo 14, D.Lgs. 81/2015, nel vietare il ricorso al lavoro intermittente in assenza di determinati requisiti, sia in capo al lavoratore che al datore di lavoro, non prevede esplicitamente un apparato sanzionatorio nello schema classico della sanzione penale o amministrativa.
La lettera circolare n. 49/2018 dell’INL ribadisce le conseguenze civilistiche della trasformazione del rapporto illegittimo in uno a tempo pieno e a tempo indeterminato, già individuate nel 2012 dal Ministero del lavoro per i casi di mancata effettuazione della valutazione dei rischi, aprendo alla possibilità che la riqualificazione avvenga anche a tempo parziale.
Introduzione
Ci sono normative che nascono non solo tecnicamente, ma anche concettualmente, male.
Già di per sé, il vietare lo svolgimento di una determinata attività senza prevederne le conseguenze sanzionatorie, pecuniarie o penali che siano, costituisce una grave e negligente mancanza.
Vietare un’attività in considerazione non dell’illegittimità in sé della condotta, ma della mancata attuazione di un adempimento accessorio e collaterale, non pare una scelta felicissima; ancor meno se l’attività vietata rappresenta la fattispecie derogatoria di uno schema contrattuale tradizionale e non ci si sia preoccupati di disciplinare le inevitabili conseguenze civilistiche (compresa la possibile sua riconducibilità alla fattispecie “madre”) della condotta interdetta.
Lasciare alla giurisprudenza il compito di definire, in assenza di sanzioni amministrative o penali, i risvolti civilistici connessi alla violazione di una data normativa è un grave azzardo. Permettere alla prassi di estendere analogicamente a determinate fattispecie i principi stabiliti dalla giurisprudenza in relazione ad altre casistiche, altrettanto inaccettabile.
Tutto ciò – come vedremo – è accaduto e sta ancora accadendo in riferimento al divieto di ricorrere al lavoro intermittente per i datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi secondo quanto disposto dell’articolo 14, D.Lgs. 81/2015. La recente lettera circolare dell’INL n. 49/2018 rivede la precedente prassi ministeriale (circolari n. 18/2012 e n. 20/2012 del Ministero del lavoro) – oggettivamente oltremisura troppo rigida nel prevedere la riqualificazione del rapporto a tempo indeterminato e a tempo pieno – e, pur consentendo oggi al personale ispettivo anche la riqualificazione del rapporto secondo la modalità a tempo parziale, non può ugualmente essere risparmiata dal nostro biasimo.
I presupposti di legittimità del lavoro intermittente
L’articolo 14, D.Lgs. 81/2015, vieta il ricorso al lavoro intermittente nei seguenti casi:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma della L. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti sospensioni del lavoro o riduzioni dell’orario in regime di Cig, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Va qui evidenziato che la disposizione citata non prevede alcuna sanzione pecuniaria, se non, appunto, il divieto tout court di utilizzo di questa forma contrattuale in assenza dei prescritti requisiti, fatto che determina un’illegittimità dal punto di vista civilistico del rapporto costituito.
Si tenga, inoltre, presente che l’impossibilità di ricorre a prestazioni di lavoro a chiamata è prevista dall’articolo 13, D.Lgs. 81/2015, anche nei casi di utilizzo di lavoratori in attività non previste dal R.D. 2657/1923 (comma 1), nell’ipotesi di carenza dei requisiti anagrafici (comma 2) e, infine di superamento del limite delle 400 giornate in un triennio (comma 3) e che solo per quest’ultima casistica si parla esplicitamente di trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Gli interventi della giurisprudenza
Le conseguenze giuridiche dell’assenza dei presupposti legali previsti per l’instaurazione di una determinata tipologia di lavoro subordinato sono state affrontate dalla giurisprudenza di legittimità in più di un’occasione, seppur in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato. Già nel 2008 la Suprema Corte, con la sentenza n. 12985, aveva infatti discusso una controversia riguardante il caso di omessa specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, statuendo che – considerato che l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro rappresenta una deroga della regola generale della durata indeterminata del rapporto – tale irregolarità avrebbe comportato la nullità parziale del contratto e, pertanto, la sostituzione della clausola nulla di apposizione del termine con la regola generale di matrice legale della durata indeterminata.
Con sentenza successiva, la n. 5241/2012, la stessa suprema Corte aveva ribadito che, nello specifico caso della mancata predisposizione del DVR, la nullità parziale del contratto stipulato contra legem avrebbe comportato la conversione nella forma comune del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una modifica della tipologia contrattuale, che era stata ritenuta la “sanzione” adeguata a colpire tali fattispecie. La decisione richiama il disposto dell’articolo 1419, comma 2, cod. civ., che impone la sostituzione di diritto delle clausole nulle con la norma imperativa, secondo il principio statuito dalla Corte Costituzionale n. 210/1992, ove si era rilevato che la nullità parziale del contratto trova una propria giustificazione nel fatto che: “se una norma imperativa è posta a protezione di uno dei contraenti, nella presunzione che il testo contrattuale gli sia imposto dall’altro contraente, la nullità integrale del contratto nuocerebbe, anziché giovare, al contraente che il Legislatore intende proteggere”.
Prime considerazioni critiche
Dal punto di vista strettamente giuslavoristico, entrambe le decisioni della Cassazione sopra citate risultano ineccepibili, in quanto, ove l’apposizione di un termine (perché di questo si disquisiva) venga ritenuta illegittima, la sua rimozione comporta inevitabilmente che il rapporto lavorativo non può più soggiacere a questo automatismo di risoluzione dell’accordo.
Da un diverso punto di vista, quello del buon senso, la soluzione imposta dagli Ermellini appare meno condivisibile, dato che, di fatto, andrebbe a imporre a entrambi i soggetti – per il futuro – una diversa disciplina contrattuale, senza considerare che la c.d. parte debole (per default il lavoratore dipendente) non solo potrebbe non averne alcun interesse, ma addirittura potrebbe riceverne nocumento.
In tale contesto, un invito alla riflessione potrebbe nascere dalla risposta alla seguente domanda: siamo certi che l’aspirazione di tutti i lavoratori sia quella di un contratto a tempo indeterminato, oltre che a tempo pieno?
Se così fosse non avrebbe alcun senso la normativa sul contratto a termine, salvo ritenerla a esclusivo uso e consumo del datore di lavoro.
Si pensi, ad esempio, sia a quel dipendente che avesse programmato qualche mese di prestazione a tempo determinato contando sul fatto (aspirazione legittima) che, al suo scadere, avrebbe maturato i requisiti per la disoccupazione o a quello a cui necessitano solo pochi mesi per maturare il diritto a un trattamento pensionistico: entrambi si troverebbero nella scomoda posizione di concordare con i propri datori la risoluzione anticipata del contratto nel rispetto del termini di preavviso.
E si consideri anche quell’altro lavoratore che, contando sulla scadenza del rapporto per rioccuparsi presso un diverso datore di lavoro, si ritrovasse con un contratto a tempo indeterminato che lo costringa a dare le dimissioni, onorando un preavviso che materialmente non può rispettare.
E tutto ciò in conseguenza di un comportamento – la mancata valutazione del rischio – non solo riferibile ad altro soggetto, ovvero il proprio datore di lavoro, ma sul quale non avrebbe alcuna possibilità di incidere o di verificarne la puntuale esecuzione.
Gli interventi della prassi
Con 2 circolari ravvicinate, la n. 18/2012 e la n. 20/2012, il Ministero del lavoro aveva di fatto esteso l’interpretazione giurisprudenziale sopra citata – formatasi, lo ribadiamo, in ambito dei contratti a termine – anche alla diversa fattispecie del contratto a chiamata, ritenendo che, in caso di assenza delle condizioni legittimanti la stipulazione del contratto, nonché in caso di violazione dei divieti indicati dall’(allora) articolo 34, comma 3, D.Lgs. 276/2003, i rapporti di lavoro dovessero essere considerati a tempo pieno e indeterminato.
Stando alle indicazioni ministeriali, il lavoratore a chiamata – volente o nolente, con o senza una sua riconosciuta diretta responsabilità – vedrebbe convertito il proprio rapporto di lavoro non solo a tempo indeterminato (sempre che non lo fosse già), ma gli verrebbe pure imposto il diritto/obbligo della prestazione lavorativa prevista per il tempo pieno.
Considerato che, pur a fronte di molteplici divieti di utilizzo del lavoro a chiamata, solo nel caso di superamento del limite delle 400 giornate in un triennio la norma parla esplicitamente di una trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato, chi scrive ritiene che qualsiasi considerazione sulle conseguenze civilistiche dell’illegittimità del rapporto avrebbe dovuto partire dal celebre brocardo latino “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
La lettera circolare n. 49/2018 dell’INL
Con questo nuovo intervento di prassi, l’INL torna sulla problematica connessa al divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, fornendo con la lettera circolare n. 49/2018 nuove indicazioni rispetto alle precedenti emanate nel 2012 dal Ministero del lavoro, che, a suo tempo, si rifacevano al consolidato orientamento della Corte di Cassazione. Tra queste, la già citata sentenza n. 5241/2012 – intervenuta, rammentiamolo, sulla stipula del contratto “atipico” a tempo determinato ai sensi dell’oggi abrogato articolo 3, D.Lgs. 368/2001 – che aveva stabilito che, in assenza della valutazione dei rischi: “la specificità del precetto, alla stregua del quale la valutazione dei rischi assurge a presupposto di legittimità del contratto, trova la ratio legis nella più intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante l’utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine, ove incidono aspetti peculiari quali la minor familiarità del lavoratore e della lavoratrice sia con l’ambiente di lavoro sia con gli strumenti di lavoro a cagione della minore esperienza e della minore formazione, unite alla minore professionalità e a un’attenuata motivazione”.
Ritenuto che il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non avessero effettuato la valutazione dei rischi costituisse norma imperativa, gli Ermellini traevano la conseguenza che, ove il datore di lavoro non provasse di aver provveduto a tale valutazione prima della stipulazione del patto, la clausola di apposizione del termine doveva considerarsi nulla e, applicando il meccanismo degli articoli 1339 e 1419, comma 2, cod. civ., il contratto di lavoro doveva considerarsi stipulato sin dall’origine a tempo indeterminato.
Alle medesime conclusioni era peraltro giunta la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la causa C-144/2004, individuando nella nullità parziale del contratto stipulato contra lege”, e nella conseguente conversione nella forma comune del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la “sanzione” adeguata a colpire tali fattispecie, atteso che “il beneficio della stabilità dell’impiego deve essere inteso come un elemento portante della tutela dei lavoratori”.
Il recente intervento dell’INL cita per ultimo, a ulteriore supporto delle tesi esposte, alcune recenti sentenze della, oggi prevalente, giurisprudenza di merito (Tribunale di Vicenza n. 343/2017 e Tribunale di Milano n. 1806/2017 e n. 1810/2017), che, pronunciandosi nei casi di stipula di contratti di lavoro intermittente (pertanto strettamente pertinenti alla fattispecie in esame) in assenza della valutazione dei rischi, avevano optato per la riqualificazione nella forma comune del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 1, D.Lgs. 81/2015.
I nuovi chiarimenti
L’INL oggi fa un deciso e apprezzabile passo avanti rispetto alle precedenti indicazioni di prassi e, rifacendosi a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, prende atto di come una modifica di rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non possa in ogni caso “confliggere con il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro – in termini quantitativi e qualitativi – realmente effettuato sino al momento della conversione”.
In sostanza, la nullità del termine opererebbe sì ex tunc, ma non potrebbe in alcun caso riconoscere il diritto del lavoratore a maggiori retribuzioni, né giustificare la pretesa degli Istituti previdenziali a maggiori contribuzioni.
Sulla base di questa premessa – che, come vedremo più avanti, non molto ci azzecca con le nuove indicazioni operative – l’Ispettorato chiarisce che alla violazione della norma imperativa di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2015, “consegue la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del citato principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale”.
Quindi, in base alle nuove indicazioni dell’INL, non più una conversione automatica e generalizzata in un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, ma anche l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale.
Considerazioni critiche finali
Come anticipato in premessa, chi scrive considera un errore prevedere l’illegittimità di un contratto in mancanza di adempimenti “accessori”, anziché in funzione dell’oggettiva antigiuridicità dell’attività in sé. Se, ad esempio, appare condivisibile il divieto di prestazioni lavorative per le donne durante il periodo di maternità, considerati i pericoli “sostanziali” per la stessa lavoratrice e il suo bambino, molto meno il divieto di stipula di un contratto intermittente (che non solo non è proibito, ma esplicitamente disciplinato dall’ordinamento), in assenza di un adempimento – spesso contestato nella sua mera mancanza “formale” – della predisposizione di uno specifico DVR. Ancora di più se questi adempimenti sono di esclusiva pertinenza di una delle parti, sui quali l’altro contraente non ha, in quanto parte debole, alcun potere né di controllo né di intervento.
Cosa dovrebbe infatti fare un lavoratore che realmente voglia prestare attività in modalità intermittente per non incappare in una riqualificazione del rapporto a tempo indeterminato, seppur a part-time? Dovrebbe chiedere al datore di lavoro la prova dell’avvenuta valutazione dei rischi? Di non aver in atto degli scioperi? Di non aver proceduto a licenziamenti collettivi negli ultimi 6 mesi?
Detto ciò, una prima obiezione – e lo diciamo molto sommessamente – riguarda il percorso logico-giuridico che cita il principio di sostituzione di diritto delle clausole nulle con la norma imperativa ex articolo 1419, comma 2, cod. civ..
Si ritiene, infatti, un controsenso aver stabilito che un certo rapporto giuridico (un contratto a tempo determinato), illegittimo in mancanza di un richiesto pre-requisito (la valutazione dei rischi), dovesse essere convertito in altro e diverso rapporto (un contratto a tempo indeterminato), che a sua volta presuppone e impone il medesimo requisito/adempimento di cui si contesta l’omissione in relazione all’originaria prestazione. E analoga censura deve oggi sollevarsi nel caso di riqualificazione del rapporto da intermittente a part-time, in quanto l’utilizzo di entrambi questi contratti di lavoro “atipici” impongono la medesima e specifica valutazione dei rischi connessa all’utilizzo di contratti flessibili. Proprio per questo non si comprende il motivo, una volta redatta la suddetta specifica sezione del DVR, di negare la legittimità, ex nunc, del rapporto, e di imporre alle parti, quale sanzione, una diversa tipologia contrattuale. Tant’è vero che nulla vieta al lavoratore di dimettersi successivamente alla riqualificazione ispettiva a tempo indeterminato, eventualmente anche a part-time, e stipulare un nuovo contratto a chiamata.
Una seconda obiezione riguarda la pretesa da parte dell’INL di individuare le conseguenze civilistiche della violazione dell’obbligo di predisposizione del DVR, ricorrendo a un’azzardata interpretazione analogica di sentenze di legittimità riferite all’utilizzo illegittimo di contratti a tempo determinato.
Pur riconoscendo corretta la conclusione – anche se, come detto, con qualche riserva – che la mancata predisposizione del DVR debba comportare la riqualificazione del rapporto tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, la fattispecie contrattuale del contratto a termine è fondamentalmente diversa da quella a chiamata. Per il primo, l’illegittimità del termine non comporta modifiche sostanziali alla prestazione concordata tra le parti e, pertanto: se concordata a tempio pieno, proseguirà come tale; se concordata a tempo parziale, come tale continuerà. Per il secondo, qualsiasi tentativo di ricondurre la prestazione alla modalità del tempo pieno o del part-time non può che rappresentare una “violenza” sulla volontà iniziale dei contraenti, per la quale – vista la modifica sostanziale del contenuto/oggetto del contratto – si sarebbe forse potuto prendere in considerazione la nullità dell’intero contratto ex articolo 1419, cod. civ. (quantomeno per il futuro), non potendo e nemmeno dovendo escludere, come vedremo, che il contraente che non lo avrebbe concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità possa essere proprio lo stesso lavoratore dipendente, presunta parte debole del rapporto.
Un’ultima obiezione, e l’avevamo più sopra già anticipato, deve essere fatta sul percorso logico richiamato dalla lettera circolare n. 49/2018 per affermare la possibilità della trasformazione del rapporto di lavoro nella modalità del tempo parziale, da operarsi, nel rispetto del principio di effettività delle prestazioni, considerando la prestazione lavorativa realmente svolta, sia in termini quantitativi che qualitativi, “sino al momento della conversione”.
Il contratto intermittente – al pari di un contratto a tempo parziale – è talvolta utilizzato in funzione delle esigenze del lavoratore, che può avere interesse a una prestazione ridotta per motivi familiari o anche per arrotondare le proprie entrate, facendo un secondo o anche un terzo lavoro. In questi casi chi scrive ritiene che le medesime esigenze – ben evidenziate dalla Direttiva Europea 1997/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – di conciliazione della vita professionale e familiare stabilite a favore del lavoratore a tempo parziale possano essere, ben a ragione, richiamate anche per il lavoratore a chiamata.
Abbiamo sopra rammentato le forti perplessità che una conversione di imperio di un contratto a termine in uno a tempo indeterminato sia un favore fatto al lavoratore. Nel caso di un contratto intermittente, chi scrive ritiene la situazione ancora più delicata e maggiori i dubbi. Si pensi a un lavoratore che abbia scelto l’intermittente non volendo avere impegni costanti e ricorrenti e si trovasse, causa un inadempimento del datore di lavoro estraneo alla prestazione lavorativa, obbligato a lavorare tutti i sabati. Oppure a un altro che ha più contratti intermittenti e utilizzasse il secondo come tappabuchi perché pagato meno del primo, e che si ritrovasse vincolato con un contratto part-time proprio al secondo datore, mentre il primo rapporto non verrebbe riqualificato perché lì vi è stata la corretta valutazione dei rischi.
Ma, soprattutto, la cosa che meno convince di tutta questa faccenda è come decidere la quantificazione in termini di orario settimanale ridotto che datore di lavoro e lavoratore dovranno rispettare. Se il dipendente a chiamata avesse effettuato nei 12 mesi precedenti la propria prestazione lavorativa sempre la domenica, non ci sarebbero in linea di massima grosse difficoltà a considerare congruo un contratto a tempo parziale per un giorno la settimana, appunto la domenica. Ma se avesse sì lavorato un giorno la settimana, ma in modalità random, quindi in giorni sempre diversi, dal lunedì alla domenica, che fare? E se, addirittura, il lavoratore avesse prestato attività per un paio di giorni negli ultimi 3 mesi, magari una volta di lunedì e l’altra di sabato, come decidere l’entità e la distribuzione della prestazione lavorativa? E, infine, se il lavoratore avesse lavorato nei 12 mesi precedenti, sempre saltuariamente e senza uno schema predefinito o definibile a posteriori, solo in alcuni mesi dell’anno?
Siamo realmente convinti che una soluzione pasticciata – che qualcuno, come abbiamo visto, vorrebbe definire secondo equità – farebbe veramente l’interesse del lavoratore?
E, ancora, sarebbe troppo malizioso pensare all’ennesimo esercizio di contorsionismo pseudo-giuridico finalizzato più al perseguimento di politiche occupazionali che alle attività di contrasto di situazioni giuridiche illegali previste a tutela di quel bene protetto (nella fattispecie la salute e sicurezza del lavoratore subordinato) – e qui il pensiero torna al divieto di attività lavorativa per le donne in maternità – che è alla base di qualsiasi norma definita imperativa?
Si segnala che l’articolo è tratto da “Strumenti di lavoro“.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: