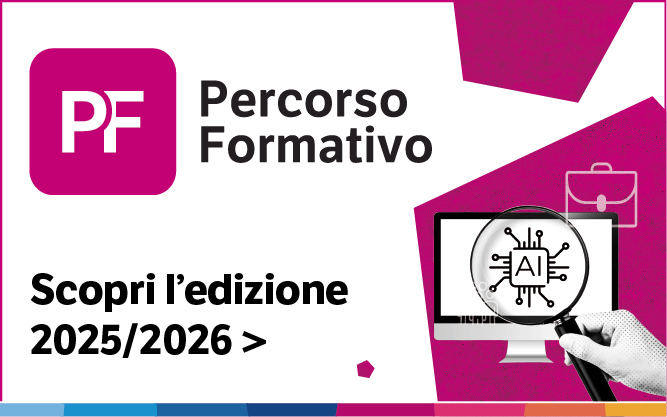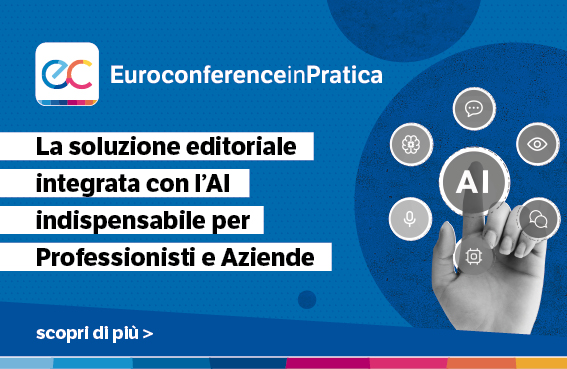Cronaca di una sentenza annunciata
di Evangelista BasileRosibetti Rubino Scarica in PDF
Con la sentenza n. 118 del 22 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha inflitto l’ennesima scure alle tutele crescenti di cui al D.Lgs. n. 23/2015, in merito – stavolta – al tetto massimo di 6 mensilità previsto quale risarcimento in caso di licenziamento illegittimo nelle imprese con un numero di dipendenti inferiore ai 15. A ben vedere, la statuizione non sconvolge e, anzi, era ampiamente “annunciata”: poiché già in precedenti interventi, la Corte delle leggi aveva fatto ben intendere che ritenesse inadeguata la soglia risarcitoria e del tutto anacronistico il criterio di computo dei 15 dipendenti, quale discrimine fra le “piccole” e le “grandi” imprese.
La pronuncia cade, tuttavia, in un momento storico particolare, se solo si pensa che poco più di un mese fa il popolo italiano era stato chiamato a partecipare al referendum proposto dalla CGIL in cui uno dei quesiti proponeva specificatamente l’abolizione del tetto di cui si discute: come è a tutti noto, l’esito è stato tutt’altro che favorevole ai promotori.
Nonostante, dunque, l’espressione della volontà popolare, la Corte ha deciso comunque di intervenire, ritenendo esistente un vulnus a cui porre rimedio. Un vulnus non già ravvisabile «nella previsione del dimezzamento degli importi delle indennità previste dagli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 23 del 2015, modulabili all’interno di una forbice, diversamente individuata in relazione a ciascun tipo di vizio, ma sempre sufficientemente ampia e flessibile»; perché tale forbice non impedirebbe al Giudice di tener conto della specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un’efficace deterrenza, e di fare applicazione dei criteri indicati dalla stessa Corte, fra i quali quello delle dimensioni dell’attività economica svolge un ruolo certamente rilevante ma senz’altro non esclusivo.
Secondo la Corte, invece, quel che confligge con i principi costituzionali, dando luogo a una tutela monetaria incompatibile con la necessaria «personalizzazione del danno subito dal lavoratore» (così si era già espressa con la sentenza n. 194/2018), è, piuttosto, l’imposizione di un tetto stabilito in 6 mensilità di riferimento per il calcolo del TFR e insuperabile.
L’effetto concreto della pronuncia è, dunque, che se per le grandi imprese, in caso di licenziamento illegittimo sanzionato con il risarcimento, il range da corrispondere al lavoratore resta compreso tra 6 e 36 mensilità (come innalzato dal c.d. Decreto Dignità), per le piccole imprese fino a 15 dipendenti, restando la regola del dimezzamento delle mensilità, con il venir meno del tetto di 6 mensilità si passa a una forbice più estesa, compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 18 mensilità, sulle quali a decidere sarà – come sempre – la discrezionalità del Giudice del lavoro.
Peraltro, in questo ormai consueto “taglia e cuci” della normativa, la Corte non ha probabilmente tenuto conto degli effetti che detta pronuncia può avere sulla conciliazione agevolata di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015. Come noto, la conciliazione agevolata prevedeva per le piccole imprese la possibilità di corrispondere al lavoratore una somma esente da tassazione e contribuzione pari a mezza mensilità per ogni anno di servizio (dimezzata, dunque, rispetto alle grandi imprese, in cui il calcolo è basato su una mensilità per anno di servizio), con un limite massimo di 13,5 mensilità.
Ad ogni modo, se stanno così le cose, è probabile che la Corte si ritrovi ben presto a dover intervenire anche sull’art. 8, Legge n. 604/1966, che ancora prevede per i vecchi assunti – non a tutele crescenti – il tetto di 6 mensilità (ora caduto per effetto della pronuncia in commento per i lavoratori a tutele crescenti). Poiché, altrimenti, sì che vi sarebbe disparità di trattamento fra vecchi e nuovi assunti a vantaggio dei nuovi, i quali primi, paradossalmente, pur possedendo una maggiore anzianità di servizio (poiché assunti ante 7 marzo 2015), si ritroverebbero con un risarcimento del danno inferiore.
La Corte conclude, poi, la sentenza invitando – ancora una volta, come già avvenuto in precedenti pronunce – il Legislatore a intervenire in merito non tanto ai profili sanzionatori in caso di licenziamento illegittimo – intervento comunque auspicabile, posto il puzzle attuale e ormai scevro di funzionalità – quanto circa il criterio distintivo fra grandi e piccole imprese. Infatti, i Giudici delle Leggi insistono sul fatto che il dato dimensionale valutato in base al numero di dipendenti sia anacronistico e non rispecchi effettivamente le capacità economiche dell’impresa, consigliando, invece, di rifarsi a criteri economici differenti, quali il fatturato o il totale di bilancio. Anche sotto questo profilo, la Corte sembra ignorare che la nozione di fatturato non necessariamente indica un’azienda sana, posto che ben potrebbe essere sovraindebitata, e che anche il totale di bilancio non è di per sé un dato infallibile su cui poter basare la sostenibilità economica per un’impresa di risarcire un lavoratore.
In ogni caso, in un contesto imprenditoriale quale quello italiano, composto quasi interamente da “piccole” imprese, pur caratterizzate da un’ottima marginalità dovuta alla qualità del prodotto e delle lavorazioni nostrane, gli effetti concreti di una pronuncia come quella oggi in commento sono potenzialmente pericolosissimi e rischiano di ingabbiare le piccole imprese, con importanti costi sia in termini di capitale umano impiegato che di produttività.