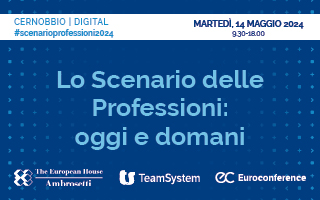Licenziamenti e “tutele crescenti”: prime pronunce e prime questioni
di Edoardo Frigerio
A poche settimane dal secondo “compleanno” del contratto a tutele crescenti, cominciano ad arrivare le prime sentenze che hanno applicato il D.Lgs. 23/2015 a casi di licenziamenti di nuovi assunti dal 7 marzo 2015. Tali pronunce, sebbene relative a casi concreti piuttosto peculiari, sono già foriere di problematiche interpretative di non poco conto.
Il licenziamento nel mondo delle “tutele crescenti”
Ormai da due anni è vigente il D.Lgs. 23/2015 che, per i nuovi assunti dalla storica data del 7 marzo 2015, ha ridisegnato le garanzie dei lavoratori inserendo il principio delle “tutele crescenti” in caso di licenziamento, rappresentando una sorta di “punto di non ritorno” tra le nuove e le vecchie tutele, già riviste dalla L. 92/2012 che aveva mandato “in soffitta” (per i licenziamenti adottati dopo il 18 luglio 2012) il “vecchio” articolo 18, L. 300/1970, e il totem della reintegrazione nel posto di lavoro, unico esito sino a quel momento in caso di vizio del licenziamento da parte di datore di lavoro con più di 15 dipendenti.
Peraltro nell’impianto apprestato dalla L. 92/2012, da cui deriva l’attuale formulazione dell’articolo 18, St. Lav., la reintegra nel posto di lavoro appare ancora oggi come uno dei diversi esiti possibili del giudizio in caso d’illegittimità del licenziamento, seppur non il preponderante, a seconda della patologia del recesso aziendale.
Viceversa, nella struttura apprestata dal D.Lgs. 23/2015, la reintegrazione nel posto di lavoro (nei licenziamenti non affetti da discriminazione o ritorsione) apparirebbe un esito assolutamente residuale: esclusa completamente nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, rimarrebbe, nel caso di licenziamento disciplinare, “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”.
Si deve ricordare al riguardo come le norme del contratto di lavoro a “tutele crescenti” si applichino, successivamente alla già ricordata data del 7 marzo 2015, ai lavoratori “che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” nonché “nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato” e ancora nel caso di quei datori di lavoro in “stabilità obbligatoria” (con meno di 16 dipendenti nella sede, filiale o ufficio nel quale ha avuto luogo il licenziamento, con meno di 16 dipendenti in più unità produttive poste nello stesso Comune o, non ricorrendo tali casi, comunque con meno di 60 dipendenti) che, in seguito a nuove assunzioni effettuate dopo il 7 marzo 2015, passino al regime tradizionalmente noto di “stabilità reale”.
Quindi tranne nei licenziamenti in cui vi sia insussistenza del fatto materiale disciplinarmente contestato al lavoratore, l’articolo 3, D.Lgs. 23/2015, stabilisce che qualora il giudice, all’esito del giudizio, rilevi l’assenza di giustificato motivo oggettivo o soggettivo o della giusta causa di licenziamento “dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.
Tali regole valgono per i dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti nella sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo al quale era addetto il lavoratore licenziato, o con più di 15 dipendenti nello stesso Comune o comunque con più di 60 dipendenti. In caso poi di violazioni formali del licenziamento (assenza della motivazione o violazione della procedura ex articolo 7 St. Lav.) le tutele sono dimezzate con la previsione di una sola mensilità risarcitoria per anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 12 mensilità; per i nuovi assunti delle piccole imprese con meno di 15 dipendenti (esclusa in ogni caso la reintegrazione) è previsto poi il dimezzamento delle indennità previste per i lavoratori dipendenti di aziende con più di 15 dipendenti.
Tali essendo i principi delineati dal D.Lgs. 23/2015, due sono gli aspetti che paiono maggiormente critici nella gestione dei licenziamenti dei lavoratori “a tutele crescenti”, che, per definizione, dovrebbero dare, in caso di illegittimità del licenziamento, esiti risarcitori di natura economica esattamente e preventivamente misurabili e “crescenti” proporzionalmente all’anzianità di servizio:
- in primo luogo l’esatto confine del concetto di “insussistenza del fatto materiale” nel licenziamento disciplinare;
- in secondo luogo i limiti entro cui circoscrivere il licenziamento nullo o discriminatorio previsto dall’articolo 2, D.Lgs. 23/2015, per evitare derive per cui tali categorie vengano espanse al fine di richiamare le alte tutele (in sostanza la reintegrazione dell’articolo 18 ante 2012) previste dalla norma.
Su quest’ultimo aspetto bisognerà attendere gli esisti giudiziari dei prossimi tempi, anche se le premesse sembrano far prevedere una dilatazione di tali categorie, nei ricorsi giudiziali di impugnazione dei licenziamenti dei lavoratori a tutele crescenti, non afflitti più peraltro dal “scivoloso” rito Fornero.
Per quanto riguarda l’individuazione degli esatti confini dell’“insussistenza del fatto materiale”, vi potrebbe essere una lettura formalistica della norma, con la conseguenza che qualsiasi fatto materiale compiuto dal lavoratore impedirebbe la reintegra; una seconda interpretazione, sicuramente più costituzionalmente orientata, prevedrebbe che il fatto materiale debba avere comunque una connotazione illecita e disciplinare; vi potrebbero però essere situazioni borderline, in cui il lavoratore incappi sì in mancanze disciplinari, ma talmente minime (un ritardo di pochi minuti; una fotocopia fatta per uso personale; una risposta sgarbata a un superiore) da porsi sul crinale tra fatto materiale avente o non avente contenuto antigiuridico, ponendosi seriamente il dubbio se, in tali casi, la tutela reintegratoria sia effettivamente preclusa, come sembrerebbe volere la norma, o meno.
In tale contesto, appare interessante verificare quali siano le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, che ha affrontato i primi casi di licenziamento di dipendenti a “tutele crescenti”. Al riguardo è opportuno subito chiarire un aspetto pratico. Con la precedente riforma del lavoro del 2012, il nuovo articolo 18 è stato subito applicato ai licenziamenti intimati dopo il 18 luglio 2012: quindi, appena pochi mesi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 92/2012, già numerosissime erano le sentenze di merito che avevano affrontato l’applicazione del nuovo articolo 18, e ora, dopo alcuni anni, innumerevoli pronunzie della Cassazione hanno formato orientamenti su molti degli aspetti più critici della riforma.
Diversamente, con il D.Lgs. 23/2015, le sentenze di merito che hanno applicato le nuove norme si contano sulle dita di una mano: questo perché le norme sulle “tutele crescenti” si applicano ai nuovi assunti dopo il 7 marzo 2015 che siano stati poi in seguito licenziati, mentre per i vecchi assunti (ancora la grande maggioranza dei lavoratori) si applicano le vecchie norme. Di conseguenza i licenziamenti di lavoratori tutelati dal D.Lgs. 23/2015 sono stati sin’ora pochi – complici anche gli sgravi contributivi per le assunzioni 2015-2016 e la possibilità dell’offerta di conciliazione prevista dall’articolo 6, D.Lgs. 23/2015 – e il contenzioso sicuramente ancora esiguo, se rapportato a quello dei licenziamenti di “vecchi assunti”.
Ad oggi, quindi, le sentenze note in tema di “tutele crescenti” sono sicuramente di numero ridotto e solo ultimamente sono giunte all’attenzione degli addetti ai lavori alcune pronunzie di cui è opportuno rendere conto per valutare come i giudici di merito abbiano incominciato a utilizzare le norme del D.Lgs. 23/2015.
Le sentenze dei Tribunali di Torino (16 settembre 2016) e di Milano (3 novembre 2016)
Vediamo quindi alcune delle poche pronunce note che hanno applicato le nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. 23/2015. Il Tribunale di Torino (sentenza 16 settembre 2016) e quello di Milano (sentenza 3 novembre 2016) si sono pronunciati, negli ultimi mesi dello scorso anno, sugli effetti delle norme sulle “tutele crescenti” in due controversie similari, concernenti il recesso del datore di lavoro in prova in caso di invalidità del patto.
Per quanto riguarda il primo caso, a un dipendente di un’azienda del torinese che svolgeva mansioni antitaccheggio all’interno di alcuni supermercati clienti del datore di lavoro veniva comunicato recesso per mancato superamento della prova. Il lavoratore impugnava il recesso affermando che il patto di prova era nullo poiché successivo all’effettivo inizio del rapporto di lavoro, formalizzato alcune settimane dopo l’inizio delle prestazioni. In giudizio emergeva che effettivamente il rapporto di lavoro era anteriore rispetto al patto di prova, cosicché il Tribunale di Torino, in linea con i principi stabiliti dall’articolo 2096 cod. civ., dichiarava la nullità del patto di prova per difetto della forma scritta contestuale o precedente all’instaurazione del rapporto lavorativo. La nullità del patto di prova aveva conseguenze, ovviamente, sulla validità del recesso: il Tribunale, richiamando recente orientamento della Cassazione, affermava quindi che il licenziamento intimato per asserito esito negativo della prova, sull’erroneo presupposto della validità della relativa clausola, non poteva ricomprendersi nella fattispecie del recesso ad nutum di cui all’articolo 2096 cod. civ., bensì in un ordinario licenziamento soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo. Conseguentemente, in tale caso, veniva dichiarata l’inesistenza del motivo addotto (ovvero l’inesistenza del mancato superamento della prova, stante la non sussistenza del patto di prova).
A questo punto il Tribunale di Torino si interrogava sulle tutele applicabili al lavoratore assunto con le “tutele crescenti”. Secondo il giudice piemontese, se il lavoratore fosse stato un “vecchio assunto”, il licenziamento per mancato superamento del patto di prova con accertata nullità del patto sarebbe stato riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 18, comma 4, L. 300/1970, stante l’inesistenza del motivo addotto. Viceversa, dovendosi applicare al licenziamento in discussione il D.Lgs. 23/2015, il giudicante – ritenendo il recesso riconducibile alla sfera soggettiva del lavoratore (quale conseguenza di richiesta del lavoratore, emersa durante l’istruttoria, di diverso inquadramento) – riconduceva la fattispecie all’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, ed evidenziava che: “il licenziamento in esame appare del tutto sfornito di giustificatezza nella sua massima accezione, essendo un licenziamento ad nutum al di fuori delle ipotesi consentite, ma nella sostanza può essere ricondotto alla sfera soggettiva del lavoratore […]; un’interpretazione estensiva della norma (ma non certo analogica, non consentita dall’avverbio “esclusivamente”), coerente con la finalità perseguite dal legislatore e imposta in chiave costituzionalmente orientata, consente di ricondurre il licenziamento in esame ad una fattispecie di licenziamento per motivi soggettivi di cui è ontologica l’insussistenza, da ritenere direttamente dimostrata per la semplice considerazione che i fatti materiali su cui è basato il recesso non sono neppure stati esplicitati”.
In base a tali considerazioni e conformemente alla previsione del dell’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, il giudice del lavoro reintegrava quindi il dipendente nel posto di lavoro, oltre a riconoscere a suo favore un’indennità risarcitoria – commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, non superiore comunque alle 12 mensilità – e ai contributi.
La decisione del Tribunale di Torino ha operato quindi un’estensione dell’applicazione della reintegrazione, che può sembrare non in linea con il dettato normativo delle “tutele crescenti”, che viceversa limita la tutela reintegratoria a una sola fattispecie ben definita, appunto quello del licenziamento disciplinare, in cui l’addebito sia manifestamente infondato. Invece il tribunale torinese, sulla base della più recente giurisprudenza in tema di nullità di patto di prova, che appresta di fatto una tutela più ampia rispetto a un “normale” licenziamento illegittimo (ciò anche, da un certo punto di vista, non conformemente allo spirito dell’articolo 2096 cod. civ.), ha ritenuto di considerare insussistente il fatto da cui derivava il licenziamento.
Anche il Tribunale di Milano, nel novembre scorso, ha affrontato il tema del recesso in occasione di prova invalido (nel caso di specie la sottoscrizione del lavoratore del patto di prova era risultata “posticcia”) arrivando alle medesime conclusioni del tribunale piemontese, ovvero comminando la reintegra del dipendente in base alla previsione dell’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015. L’approdo del giudice ambrosiano è derivato dal fatto che, a suo dire, “l’indimostrata sussistenza di un valido patto di prova apposto per iscritto al contratto di lavoro in esame comporta l’ingiustificatezza del licenziamento impugnato, ex artt. 1 e ss. L. n. 104/1966, in quanto fondato su una ragione inesistente e, cioè, sull’asserito mancato superamento di un patto di prova in realtà non validamente stipulato per iscritto dalle parti e, quindi, nullo e inefficace ex art. 2096 c.c. […]. Dall’accertata ingiustificatezza del recesso intimato per insussistenza del fatto materiale contestato discende, ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 23/2015, l’illegittimità e quindi l’annullamento del licenziamento impugnato con condanna della resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro”.
La pronuncia del Tribunale di Milano 5 ottobre 2016
Diversa fattispecie, ma uguale risultato, è quello a cui è approdato il Tribunale di Milano in una sentenza del 5 ottobre 2016. In questo caso il datore di lavoro aveva licenziato un dipendente a “tutele crescenti” per superamento del periodo di comporto, adducendo però non questa motivazione ma, improvvidamente, sostenendo la giusta causa del recesso ex articolo 2119 cod. civ., in conseguenza, a suo dire, dell’eccessiva morbilità del lavoratore. Altrettanto improvvidamente il datore di lavoro rimaneva contumace nel successivo giudizio, intentato dal lavoratore per vedersi riconoscere l’invalidità del recesso per non essere stato effettivamente superato il periodo di comporto. In tale situazione di contumacia datoriale il giudice del lavoro, giocoforza, non poteva che ritenere insussistente la giusta causa di licenziamento e illegittimo il licenziamento per “manifesta insussistenza della giusta causa addotta, cui seguiranno le conseguenze di cui all’art. 3 2° comma, con ordine di reintegrazione del ricorrente e condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento […] in misura non superiore a dodici mensilità”.
Le tre pronunzie esaminate hanno quindi “espanso” la tutela – che il D.Lgs. 23/2015 appresta solo ai licenziamenti disciplinari “in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento” – anche a situazioni (recesso in costanza di patto di prova nullo; licenziamento per eccessiva morbilità) apparentemente lontane dal licenziamento “per mancanze”.
Tuttavia, nei casi esaminati, la componente latamente disciplinare del licenziamento era comunque presente e, pertanto, la sussunzione della fattispecie nell’ambito dell’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, appare più comprensibile. Trattasi comunque di tre vicende del tutto peculiari, non certo frequentemente ripetibili: dire quindi che la reintegrazione del posto di lavoro – spauracchio degli imprenditori e totem che, su monito dell’Europa, i Governi dell’ultimo quinquennio hanno ormai legislativamente abbattuto – possa rientrare “dalla finestra”, pare ancora prematuro. I segnali che la reintegrazione, e la tutela forte del dipendente, anche a “tutele crescenti”, non sia ancora “pensionata” sono evidenti, specie per il datore di lavoro troppo “spericolato”. Si vedrà nei prossimi mesi se si sarà trattato solo di un ritorno di fiamma della vecchia tutela reale del posto di lavoro o se gli orientamenti, espressi dalle tre sentenze esaminate, si consolideranno.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Il giurista del lavoro“.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: